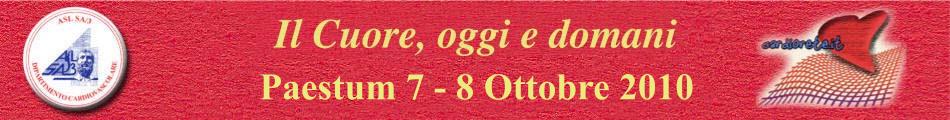
Com’è cambiata e come cambierà la Cardiologia Ospedaliera
G. Rosato; F.Candelmo; E. Di Lorenzo; T. Lanzillo; F. Manganelli;L. Marino; F. Rotondi.A.O.R.N. San G. Moscati Avellino
L’Istituto Superiore di Sanità ha comunicato quest’anno un dato di estremo interesse: rispetto al 1980, nell’anno 2000 si sono avute 42.930 morti in meno per anno per malattie cardiovascolari. Questo è dovuto per il 58% a misure di prevenzione e per circa il 40% a trattamento delle malattie. Ciononostante la patologia cardiovascolare costituisce di gran lunga la prima causa di morte in Italia. Il suo impatto in termine di mortalità, morbosità ed anche sui ricoveri ospedalieri si mantiene elevato. Alla luce dei più recenti documenti scientifici e di consenso è utile che tutte le strutture interessate alla diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie del sistema cardiovascolare cerchino il massimo raccordo operativo e funzionale al fine di consentire al paziente un inquadramento complessivo della malattia e l’identificazione di un percorso diagnostico terapeutico appropriato. La cardiologia italiana costituisce senza dubbio un patrimonio assai importante nel SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE. Gli enormi progressi verificatesi negli ultimi decenni e il travolgente ritmo di crescita delle conoscenze cardiologiche degli ultimi anni richiedono un costante aggiornamento relativamente a quattro aspetti fondamentali:
1. La scienza cardiologia di base 2. Le procedure diagnostiche 3. Le possibilità terapeutiche 4. L’assetto organizzativo
Il cambiamento è però multifattoriale. Esistono problematiche legate:
Ø Alla tipologia dei pazienti Ø Agli aspetti etici, legali e culturali Ø Alle competenze territoriali e cliniche Ø Alle risorse economiche Ø Alle risorse umane disponibili
Una delle principali criticità della Cardiologia ospedaliera riguarda innanzitutto il problema delle risorse. Se è vero che le malattie cardiovascolari continuano ad essere anche nel nostro Paese la causa principale di morte e di invalidità, gli investimenti in termine di prevenzione, innovazione tecnologica, cura e riabilitazione dovrebbero essere significativamente diversi. L’evoluzione poi verso la REGIONALIZZAZIONE della Sanità ha reso i cardiologi più consapevoli di dover recuperare la “CENTRALITÀ DEL PAZIENTE” in un ottica di continuità assistenziale fra ospedale e territorio. Sicuramente le qualità dell’assistenza erogata nelle oltre 800 strutture cardiologiche del nostro Paese è di buon livello ed il contributo della cardiologia italiana in ambito di programmazione sanitaria è stato notevole. Già nel 1981 fu elaborato dall’ANMCO lo schema di Piano per l’assistenza cardiologia in Italia. Nel 1986 sempre l’ANMCO elaborò i criteri ed i modelli organizzativi in cardiologia. L’ANMCO e la SIC nel 1996 pubblicarono il testo”STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE funzionale della Cardiologia”. Il 2003 la FIC aggiornò il testo adeguandolo ai tempi. Nel 2009 sempre la FIC ha ritenuto opportuno la RIEDIZIONE del documento STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE funzionale della Cardiologia in considerazione di emergenti criticità e proposte di cambiamenti:
Ø IPOTESI di nuovi modelli organizzativi ospedalieri ( ospedale per “INTENSITA’ DI CURE”) Ø RUOLO DELLE UTIC SPOKE Ø DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE Ø FRAMMENTAZIONE DELLA CARDIOLOGIA (sub specialità) Ø CONTINUITA’ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO
Il documento, inteso come una iniziativa di salute pubblica ha come destinatari la comunità medica e tutti coloro che hanno compiti organizzativi e decisionali nella SANITA’. Il contenuto è rappresentato da una proposta di modelli organizzativi per rispondere ai bisogni generati dalla epidemiologia evolvente e per rispondere alla crescente domanda di salute dei cittadini. Una criticità emergente riguarda il futuro della cardiologia in Italia ed in particolare quello delle UTIC SPOKE cioè di quelle inserite in strutture di cardiologia non dotate di Emodinamica interventistica. La delegittimazione di queste UTIC senza Emodinamica o con Emodinamica non interventistica mette in serio pericolo anche l’esistenza delle rispettive cardiologie per le quali sarebbe arduo sostenerne l’identità. Le condizioni ritenute essenziali da tutto il mondo cardiologico per la legittimazione di tali strutture sono le seguenti:
La scelta fatta di realizzare la rete integrata in cardiologia sposta l’attenzione dalla PRESTAZIONE all’intero PERCORSO ASSISTENZIALE con l’obiettivo che questo possa svolgersi in modo UNITARIO per:
Ø Garantire continuità assistenziale Ø Evitare duplicazioni di servizi Ø Favorire la comunicazione in medicina
Le condizioni poste a base perché la rete cardiologia integrata funzioni è che vi sia una cultura organizzativa per intendersi sui percorsi e sugli obiettivi, una rete informatica per comunicare, una rete amministrativa per non frazionare le risorse. L’organizzazione delle reti interospedaliere per la gestione del paziente con infarto miocardio acuto ha portato, negli ultimi anni, una significativa riduzione della mortalità per infarto, e sono diventate un modello di riferimento in fase di costituzione come quelle per STROKE. Infatti la neurologia ha seguito la traccia segnata dalla cardiologia sostituendo lo slogan “IL TEMPO E’ MUSCOLO” con quello “IL TEMPO E’ CERVELLO” e cercando soluzioni, come le STROKE UNITS, per la terapia precoce dell’ictus mediante trombolisi, utili a realizzare una rete integrata per il trattamento dell’ictus cerebrale acuto. La valutazione di esito rappresenta il vero metro di efficienza. Quale esito ha avuto il lavoro della cardiologia negli ultimi 25 anni? Le Unità coronariche hanno portato la mortalità per infarto dal 30% degli anni sessanta al 15% degli anni settanta. Successivamente la mortalità è scesa, con la trombolisi al 10,7%, fino all’attuale 5% in epoca di angioplastica primaria. Necessario è stato poi nel tempo favorire la trasformazione dell’UNITA’ CORONARICA ad UNITA’ DI TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA. Ciò si è verificata negli ultimi anni sulla spinta di diversi fattori quali:
Ø La crescente complessità clinica dei pazienti afferiti per procedure di rivascolarizzazione miocardia per cutanea Ø La diffusione della rianimazione preospedaliera (afflusso di un crescente numero di pazienti vittime di arresto cardiaco) Ø Trattamento intensivo ad alto contenuto tecnologico dei pazienti con scompenso cardiaco avanzato Ø Afflusso di cardiopatici con comorbidità da trattare in area intensiva Ø L’incremento di patologie cardiovascolari negli anziani Ø La gestione dell’instabilizzazione in portatori di dispositivi
Nella RETE per l’emergenza cardiovascolare l’unità di terapia intensiva cardiologia, di qualsiasi livello, viene ritenuta il PERNO attorno al quale ruota l’organizzazione dell’assistenza al cardiopatico acuto in quanto è al Centro della rete INTEROSPEDALIERA, e ancora al CENTRO della rete INTRAOSPEDALIERA per l’assistenza del cardiopatico instabilizzato, ed è al CENTRO del DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE per le proprie specifiche competenze. La strategia della RETE rappresenta pertanto il punto di riferimento per prevenire e curare con efficacia. Il modello HUB e SPOKE individuato garantisce l’equità dell’accesso a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui si manifesta il bisogno di assistenza. Tale modello si fonda sull’interazione e sulla complementarietà funzionale dei PRESIDI e delle STRUTTURE, indipendentemente dalla loro collocazione fisica ed amministrativa. Quando una determinata soglia di complessità assistenziale viene superata, si trasferisce la sede dell’assistenza da una UTIC ad un’altra più complessa, in base a protocolli concordati, condivisi, DELIBERATI. Sia le UTIC HUB e le UTIC SPOKE sono strutture di riferimento ed intervengono in modo differenziato e sinergico in base alle rispettive dotazioni e alla complessità dei casi assistiti. I Laboratori di diagnostica ed interventistica cardiovascolare rappresentano lo snodo decisivo nel percorso diagnostico terapeutico del cardiopatico acuto. Il rapido incremento del numero e la capillare ancorché perfettibile distribuzione delle sale di emodinamica sull’intero territorio nazionale consentono oggi la rivascolarizzazione tempestiva della maggior parte dei pazienti con infarto miocardio acuto. Il modello della rete quindi sposta l’attenzione della singola prestazione all’interezza del percorso e permette che singole prestazioni siano assicurate da strutture diverse coordinate fra di loro. Se la rete per l’emergenza cardiologia costituisce la risposta ORGANIZZATIVA, STRUTTURALE, CULTURALE alle necessità di assistenza del cardiopatico acuto, la RETE per il cardiopatico cronico rappresenta la risposta al bisogno di cure cardiologiche croniche. L’aggettivo “cronico” non va inteso come sinonimo di “senza speranza di guarigione” o “invalidante” o “terminale” bensì va riferito al paziente portatore di una patologia cardiovascolare, sintomatica o meno, destinata a persistere nel tempo ed a rischio di progressione e riacutizzazione, e tale quindi da necessitare una presa in carico globale da parte di un team medico-infermieristico. Il principio della continuità assistenziale ha un ruolo centrale in tutti i disegni organizzativi ed assistenziali del paziente cronico e deve favorire il più possibile l’integrazione organica fra le diverse strutture ospedaliere e fra Ospedale e Territorio. L’approccio multidisciplinare è strumento insostituibile per la cura delle patologie croniche tipicamente negli anziani. Sulla base delle specifiche caratteristiche del paziente e della fase della malattia, la presa in carico dovrà avere carattere di flessibilità mettendo comunque sempre al primo posto la necessità di una competenza ed esperienza cardiologia adeguata alla tipologia dei pazienti in carico. Il concetto di gradualità delle cure ben si adatta anche al paziente cronico che necessita di una risposta differenziata e complementare di fronte alla molteplicità delle esigenze cliniche, della tipologia delle strutture e dei differenti livelli di competenze all’interno dell’offerta assistenziale ospedaliera e territoriale. Il modello organizzativo che garantisce la gradualità delle cure è quello basato sul principio della rete cardiologia integrata tra ospedale e strutture sanitarie territoriali (ambulatori cardiologici, distretti, assistenza primaria e domiciliare) con al centro il paziente cardiopatico cronico. La rete collega medici di medicina generale, ambulatori specialistici, reparti di cardiologia, centri di riferimento con l’intera gamma delle disponibilità tecnologiche, dall’emodinamica all’elettrofisiologia, dalla cardiochirurgia al programma di trapianto cardiaco, dando forma, anche nella rete per il paziente cronico, al modello HUB e SPOKE. Un sistema che garantisca la continuità delle cure è fondamentale nell’assistenza ai pazienti acuti, subacuti e cronici, nella gestione dei quali soltanto un modello organizzativo dipartimentale è in grado di assicurare la necessaria integrazione tra le diverse articolazioni assistenziali (ambulatori, day hospital, day surgery, day service, ospedalizzazione domiciliare, cure primarie, strutture per acuti, strutture residenziali, strutture riabilitative, ecc….) riportando ad UNITA’ momenti assistenziali diversi per tipologia ed intensità di cura. Il modello dipartimentale, solidamente supportato da motivazioni di ordine demografico, epidemiologico, socio-culturale, tecnico, organizzativo ed economico, verrà disegnato scegliendo di volta in volta la tipologia che meglio corrisponde alla specifica realtà, venendo a configurarsi come DIPARTIMENTO aziendale o interaziendale, strutturale o funzionale, ospedaliero, extraospedaliero o misto. La flessibilità con cui il DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE può prendere forma nei diversi contesti sanitari ne garantisce la fattibilità e l’operatività. Tale modello è in grado di generare cultura, sviluppare sistemi informaci interattivi, favorire e promuovere l’integrazione interprofessionale ed il lavoro di gruppo, implementare sistemi di verifica della Qualità, permettere l’elaborazione di linee guida, diffondere programmi di formazione. Il ruolo del DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE nell’assicurare la GRADUALITA’ delle cure si esprime in:
Ø programmi nazionali di prevenzione cardiovascolare
• cure in ospedale - paziente in emergenza, bisognoso di sostegno delle funzioni vitali (Pronto Soccorso cardiologico o terapia intensiva cardiologia) - paziente acuto non differibile (terapia intensiva o reparto cardiovascolare) - paziente bisognoso di ospedalizzazione programmata per patologia medica o chirurgica non altrimenti trattabile (Reparto medico-chirurgico cardiovascolare) - paziente trattabile in regime di ospedalizzazione diversa - paziente in Riabilitazione in regime di degenza
• cure fuori dall’ospedale - paziente ambulatoriale - paziente in fase di recupero funzionale (riabilitazione ambulatoriale) - paziente cronicamente stabilizzato, con differente grado di dipendenza, bisognoso di assistenza residenziale - paziente bisognoso di assistenza domiciliare - rapporto con il Distretto e interazione con il medico di medicina generale.
Il DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE consente il superamento dei vincoli delle SOTTOSPECIALITA’, con soluzioni duttibili e innovative per una CARDIOLOGIA che cambia. Valgono per esempio il ridimensionamento della cardiochirurgia tradizionale e della chirurgia vascolare a opera delle nuove soluzioni interventistiche, che vedono spesso i cardiologi risolvere problemi che erano dei chirurghi. Solo l’integrazione culturale e logistica all’interno del DIPARTIMENTO d’organo permette di ottenere il vantaggio della sinergia tra l’innovazione tecnologica, capacità tecniche, esperienza clinica, appropriatezza di indicazioni e assistenza adeguata. Oggi in alcune Regioni si sta percorrendo l’ipotesi di un nuovo modello di assistenza ospedaliera incentrato sulla “INTENSITA’ delle cure”. Il livello 1,unificato, comprende la terapia intensiva e subintensiva. Il livello 2, articolato almeno per area funzionale, comprende il ricovero ordinario e il ricovero a ciclo breve che presuppone la permanenza di almeno una notte in ospedale. Il livello 3, unificato, è invece dedicato alla cura postacuzie o Low care. Se applicato alla Cardiologia tale modello comporta il rischio di frammentare collaudati percorsi assistenziali e di rappresentare un regresso in termini clinici ed organizzativi, riducendo l’efficacia delle cure e disperdendo un patrimonio di esperienza accumulata in oltre 40 anni di evoluzione della disciplina. Tale modello inoltre espone al futuro rischio di perdita della identità e specificità culturale cardiologia, non riflette l’attuale CLINICAL COMPETENCE, determina commistione di altre specialità nel continuum clinico-diagnostico e teraupetico cardiologico, perdita di credibilità da parte del cittadino che si rivolgerebbe ad altre strutture specialistiche, degenze brevi non supportate da un’assistenza del territorio debole, scomparsa delle UTIC dei piccoli ospedali e mutamento della rete HUB e SPOKE. La cardiologia italiana invece propone il modello della “GRADUALITA’ DELLE CURE” all’interno del DIPARTIMENTO CARDIOVASCOLARE. In tale contesto andranno ricercate soluzioni di efficienza organizzativa che favoriscano il contenimento dei costi. La cardiologia, pur nelle sue diverse sottospecialità, è organizzata in percorsi unitari incentrati sul cardiopatico. L’ipotesi di assegnare il cardiopatico non ad una continuità culturale ma ad una per “intensità di cura” non appare ragionevole. Il modello “gradualità delle cure” potrà coniugare l’efficienza con l’efficacia e con la valorizzazione delle capacità professionali degli operatori tenendo conto degli specifici contesti assistenziali. Una nuova missione? Non credo UNA NUOVA VISIONE? Senza dubbio si. La visione di chi vuole restituire unità non solo al sistema cardiovascolare, ma alla persona malata.
|