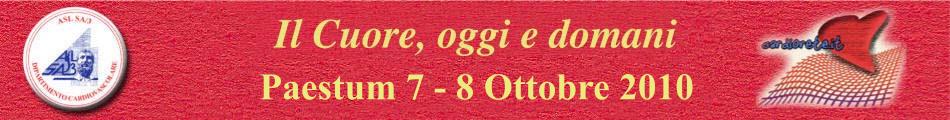
PROCESSO ALLA RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE La difesa Carmine Riccio, Cesare Greco, Marco Malvezzi Caracciolo U.O. Cardiologia Riabilitativa A.O. San Sebastiano Caserta
Nel 1995 le Clinical Practice Guidelines on Cardiac Rehabilitation dell’AHCPR definivano l’attività della Cardiologia Riabilitativa come un intervento a lungo termine omnicomprensivo articolato in valutazione medica, prescrizione dell’esercizio, modificazione dei fattori di rischio, interventi educazionali e di counseling[i]. La Cardiologia Riabilitativa è quindi una branca della cardiologia che si occupa nella sua totalità della gestione del paziente post-acuto, diretta da un cardiologo[ii] che si avvale di un’equipe multidisciplinare capace di lavorare in team. Le Task Force della ESC, facendo rifermento ai dati scientifici disponibili, hanno ripetutamente sottolineato che la stessa prevenzione secondaria dovrebbe preferibilmente essere effettuata attraverso la Cardiologia Riabilitativa [iii], [iv] mentre nel 2007 due documenti dell’ACC/AHA hanno definito i core components della Cardiologia Riabilitativa[v] e le misure di performance che dovrebbero essere adottate per verificarne l’efficacia[vi]. Nel 2008 sono state pubblicate le Linee Guida promosse in Italia dall’ASSR che sono rivolte al medico di medicina generale e ai programmatori sanitari[vii]. La riabilitazione cardiologica è inoltre raccomandata con il più alto livello di evidenza (Classe I) dalle Linee Guida della European Society of Cardiology , dell’American Heart Association e dell’American College of Cardiology per il trattamento dei pazienti con cardiopatia.[viii] , [ix], [x]. Analogamente essa viene raccomandata anche dopo un episodio di scompenso cardiaco[xi] o dopo un intervento cardochirurgico[xii]. Malgrado queste importanti e significative prese di posizione il processo di cura in questo settore incontra ancora numerosi ostacoli: le strutture di Cardiologia Riabilitativa non solo in Italia, ma anche negli USA[xiii], non sono ancora distribuite in maniera omogenea e da più parti si lamenta un gap tra la domanda potenziale di riabilitazione cardiologica e la reale richiesta di questo tipo di servizio . Ciò è dovuto alla presenza di una serie di barriere che tuttora limita l’accesso a queste strutture specialistiche , soprattutto di tipo culturale, poiché l’ assistenza cardiologica è attualmente più orientata verso la fase acuta che verso la fase post-acuta o cronica. Vi sono infine ostacoli di tipo economico circa la sostenibilità di programmi di esercizio e prevenzione secondaria articolati in prestazioni multidisciplinari e quindi apparentemente costose; in realtà è dimostrato che la riabilitazione cardiologica è un intervento con un rapporto costo/efficacia molto favorevole sia dopo un evento coronarico [xiv] che dopo un episodio di scompenso [xv] ; esso migliora la prognosi riducendo le reospedalizzazioni e quindi le spese per l’ assistenza ed i suoi costi per anno di vita salvato sono paragonabili a quelli di altre terapie consolidate come i trattamenti antidislipidemici, la trombolisi o l’angioplastica coronarica. L’elemento più paradossale è comunque rappresentato in Italia dalla contraddizione tra l’ esistenza di indicazioni generalizzate alla riabilitazione cardiologica, contenute nelle linee guida sopra citate , e la realtà di un ricorso episodico a questo percorso assistenziale nella realtà della nostra assistenza sanitaria. Si impone pertanto alla cardiologia italiana una profonda riflessione al fine di spiegare le profonde discrepanze tra la dottrina teorica e la realtà quotidiana e di avanzare proposte in grado di modificare positivamente la situazione attuale. Ma a questo punto quello che è una posizione di difesa diventa un atto di accusa: per quale motivo vi è un sottoutilizzo delle possibilità offerte dal modello di cardiologia riabilitativa? Un’offerta che in alcune regioni italiane, vedi in particolare Marche e Sardegna, è ancora deficitaria, una modalità di rimborso che incentiva una tipologia degenziale di riabilitazione che non può essere il modello da applicare a tutti i pazienti, la scarsa fiducia che ancora serpeggia tra gli addetti ai lavori sono alcune delle motivazioni che vengono generalmente chiamate in causa per giustificare il mancato ricorso alla cardiologia riabilitativa. Di fatto i centri di riabilitazione accolgono in oltre il 60% dei casi pazienti post cardiochirurgia,nei quali una spinta determinante al ricovero in cardiologia riabilitativa è stata data in un fase iniziale dalla necessità dei cardiochirurghi di accelerare il turnover dei loro pazienti. Secondo tutte le LLGG internazionali i pazienti che sono stati sottoposti a BPAC o a riparazione o sostituzione valvolare sono naturali candidati a ricevere i programmi offerti dalla Cardiologia Riabilitativa (CR)4,[xvi] Autorevoli pubblicazioni hanno chiaramente dimostrato che la CR migliora l’outcome dei pazienti rispetto alla “usual care” della pratica clinica verosimilmente per il fatto che i programmi di CR focalizzano speciali risorse e attenzione alla modifica dei fattori di rischio CV, alla ottimizzazione della terapia, alla educazione ed al counselling, favorendo in tal modo un effettivo cambiamento dello stile di vita e una miglior aderenza alla terapia. In aggiunta, la CR in ambito degenziale dopo cardiochirurgia rappresenta un ponte tra la dimissione dalla fase acuta e il ritorno ad una vita indipendente a domicilio, favorendo la stabilizzazione e l’autonomia funzionale avviando nello stesso tempo il processo di prevenzione secondaria. Soprattutto nei pazienti a rischio medio-alto di eventi, quali gli anziani, le donne, e i portatori di comorbidità e disabilità un passaggio anche precoce in CR degenziale permette di assicurare una appropriata gestione clinica, un più rapido recupero funzionale, e contemporaneamente l'ottimizzazione terapeutica e l'avvio di un programma multidimensionale di prevenzione secondaria. Offerta assistenziale attuale L’ISYDE è una rilevazione dell’attività dei 165 centri di riabilitazione cardiologica partecipanti sui 190 presenti in Italia, tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2008 . Nei 14 giorni di durata dello studio venivano ricoverati nei 2421 letti di degenza cardiologica riabilitativa 2281 pazienti con una degenza media di 18 giorni ed una proiezione annuale di accoglienza per circa 60.000 pazienti. Nei 352 letti di day-hospital la durata media degli programmi riabilitativi era di 23 giorni e negli ambulatori gli accessi erano in media 14, distribuiti entro un periodo di tempo medio di 87 giorni. Per quanto riguarda le indicazioni alla riabilitazione cardiologica, è interessante notare che ben il 55.8% dei pazienti erano provenienti dalle cardiochirurgie ( 30.1% dopo by-pass aorto- coronarico, 15.8% dopo chirurgia valvolare, 7.5% dopo chirurgia toracica) mentre solo l’8.8% perveniva in riabilitazione dopo una sindrome coronarica acuta, il 12.2% dopo un’angioplastica coronarica e l’1.8% dopo un ricovero per angina pectoris. Analogamente solo il 12.5% dei pazienti perveniva in riabilitazione cardiologica dopo un episodio di scompenso cardiaco. Questi dati, proiettati sul periodo di un anno testimoniano la capacità globale delle strutture di riabilitazione di circa 60.000 pazienti/anno con degenza media 18 giorni : di questi, con buona approssimazione, 35.000 dopo intervento cardochirurgico, 15.000 pazienti dopo sindrome coronarica acuta o PTCA e 7.000 dopo un episodio di scompenso cardiaco. Fabbisogno assistenziale I seguenti dati sul fabbisogno assistenziale sono stati ricavati da un’analisi dell’ epidemiologia dell’infarto miocardico acuto, dello scompenso cardiaco e degli interventi cardiochirurgici compiuta attraverso i dati del SIO (Servizio Informativo Ospedaliero) o dei data base della società di chirurgia cardiaca (SICHR) ed emodinamica (SICI-GISE). E’ opportuno valutare le ricadute in termini assistenziali di una applicazione letterale delle indicazioni delle Linee Guida sopra citate, facendo riferimento per omogeneità , quando possibile, a dati relativi all’anno 2004. Nel 2004 venivano dimessi vivi dagli ospedali italiani e quindi erano in linea di principio elegibili per un programma di riabilitazione 90.175 pazienti con diagnosi principale di infarto miocardico acuto; nello stesso anno venivano dimessi vivi e quindi erano elegibili per un programma di riabilitazione 134.937 pazienti con diagnosi principale riconducibile ad episodio di scompenso cardiaco. Analogamente nel 2003 venivano eseguiti interventi maggiori di cardiochirurgia su 50.000 pazienti e nel 2004 115.000 angioplastiche coronariche. Anche ammettendo che tra le ultime categorie di pazienti possano esserci state delle sovrapposizioni ( pazienti infartuati sottoposti ad angioplastica e poi a bypass aorto-coronarico) è evidente che la mole di pazienti che, in linea di principio, sono candidati ad un intervento di riabilitazione cardiologica è enorme ed eccede di gran lunga le potenzialità delle strutture riabilitative cardiologiche italiane, assommando tra i 250.000 ed i 300.000 pazienti Il modello perseguibile e realizzabile nel mondo reale dovrebbe prevedere: 1) Ogni paziente che abbia superato la fase acuta di una cardiopatia necessita di un’ assistenza a medio e lungo termine congrua al tipo di patologia alla sua gravità. Tale assistenza dovrà essere fornita nelle strutture idonee ai bisogni: nella maggior parte casi sarà sufficiente un programma strutturato di Riabilitazione/prevenzione secondaria ambulatoriale da gestire direttamente dalle strutture per acuti; in altri casi a media complessità/gravità la fase subacuta potrà essere gestita ambulatorialmente o in DH da strutture riabilitative dedicate (capaci di garantire comuque un intervento multifattoriale e polispecialistico) ; infine in una minoranza di casi sarà necessario il ricovero riabilitativa in strutture specialistiche dedicate . Nel presente documento sarà affrontato estesamente il quesito circa le indicazioni alla riabilitazione degenziale, intendendo per questa la degenza ordinaria e non in DH..
2) E’ necessario introdurre, accanto a quello della indicazione alla riabilitazione cardiologica, il concetto di “priorità” dell’accesso alle strutture degenziali di cardiologia riabilitativa. Occorre cioè definire con sufficiente precisione quali sono le categorie di pazienti per i quali l’intervento cardiologico riabilitativo non è solo utile ma irrinunciabile e prioritario ed ai quali va assicurato l’accesso alle strutture dedicate. 3) Per identificare le categorie con indicazione irrinunciabile ad un percorso riabilitativo inizialmente degenziale occorre riferirsi al livello di rischio delle popolazioni di pazienti, garantendo che le prestazioni riabilitative siano fornite innanzitutto ad i pazienti a rischio clinico più alto, nella convinzione che l’intervento su questi pazienti sia più efficace in termini di outcome. 4) Vi è comunque la necessità di ridefinire le modalità con cui si svolge l’attività di riabilitazione cardiologica poiché, anche indicando la priorità dell’intervento riabilitativo per le minoranze di pazienti a più alto rischio nelle diverse patologie, ragionevolmente si eccedono le potenzialità organizzative degenziali attuali della riabilitazione cardiologia.. E’ quindi necessario riformulare l’offerta riabilitativa attraverso una qualificazione del ricorso alla riabilitazione degenziale, sia in termini di selezione dei pazienti che di durata della degenza, ed attraverso l’aumento dell’offerta di riabilitazione ambulatoriale o anche domiciliare per i soggetti a rischio più basso. 5) “ E’ quindi necessario che l’ offerta riabilitativa si articoli in modo organico su diversi livelli, potenziando in modo cospicuo le strutture ambulatoriali sino ad ora assolutamente carenti in modo da consentire un più appropriato utilizzo delle strutture specialistiche degenziali, che comunque devono essere incrementate e più equamente distribuite sul territorio nazionale, per far fronte alle crescenti richieste e a tipologie di pazienti sempre più complessi” Occorre in sostanza modulare l’intervento riabilitativo-preventivo secondo livelli progressivi [xvii]: 1 assicurare a tutti una corretta informazione/educazione sulla propria malattia e sulle abitudini di vita sa seguire 2 pazienti selezionati devono essere avviati a percorsi di riabilitazione-prevenzione secondaria da effettuare a livello ambulatoriale, agili e poco costosi 3 pazienti a rischio più alto per complessità o comorbidità devono accedere ad un programma di Cardiologia Riabilitativa inizialmente degenziale e poi ambulatoriale, di tipo omnicomprensivo. Conclusioni
In base alle indicazioni alla riabilitazione cardiologica definite come prioritarie dal presente documento dovrebbero, secondo stime che appaiono verosimili, essere avviati prioritariamente ad un percorso riabilitativo inizialmente degenziale circa 30.000 cardioperati, 30.000 pazienti reduci da infarto miocardico acuto e 35.000 pazienti dopo un episodio di scompenso ogni anno. La potenzialità attuale delle strutture degenziali probabilmente non consente di accogliere un numero così elevato di pazienti, soprattutto qualora sia mantenuta l’attuale degenza media che è di 18 giorni: è quindi evidente la necessità di riformulare i percorsi assistenziali . Le stesse strutture riabilitative dovranno specializzare la loro attività per rispondere ad esigenze fortemente differenziate ed alcune di esse dovranno non solo essere inserite nella rete del cardiopatico cronico ma avere rapporti anche con la rete interospedaliera per la cardiopatia ischemica acuta. . Le modalità di modifica ed ammodernamento dei percorsi assistenziali della cardiologia riabilitativa esulano dai compiti di questo documento e saranno elaborate dalla società scientifica di settore e concordate con le altre società scientifiche ma soprattutto con le autorità regolatorie regionali . Si ritiene, quindi, che l’ analisi dell’epidemiologia clinica della fase post-acuta apra una prospettiva nuova all’azione della cardiologia riabilitativa . questa azione potrà essere portata avanti in modo efficace solo in stretto collegamento ed accordo con la cardiologia ospedaliera che opera nella fase acuta . [i] Wenger NK, Froelicher ES, Smith LK et al. Cardiac Rehabilitation. Clinical practice guidelines. AHCPR and NHLBI, October 1995
[ii] King ML, Williams MA, Fletcher GF et al. Medical director responsibilities for outpatient cardiac rehabilitation/secondary prevention programs: a scientific statement from the American Heart Association/American Association for Cardiovascular and pulmonary Rehabilitation. Circulation 2005; 112: 3354-60.
[iii] Giannuzzi P, Saner H, Bjomstad H et al. for the WG on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology of the European Society of Cardiology. Secondary prevention through cardiac rehabilitation. Eur Heart J 2003; 24: 1273-8.
[iv] Piepoli MF, Corrà U, Benzer W et al. Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010 in press [v] Balady GJ, Williams MA, Ades PA et al. Core components of cardiac rehabilitation/secondary prevention programs: 2007 update. A scientific statement from AHA and AACPR. Circulation 2007; 115: 2675-82.
[vi] Thomas RJ, King M, Lui K et al. AACVPR/ACC/AHA 2007 performance measures on cardiac rehabilitation for referral to and delivery of cardiac rehabilitation/ secondary prevention services. J Am Coll Cardiol 2007; 50: 1400-33.
[vii] Griffo R, Urbinati S, Giannuzzi P et al. Linee guida nazionali su cardiologia riabilitativa e prevenzione secondaria: sommario esecutivo. G Ital Cardiol 2008; 9: 286-97.
[viii] Antman EM, Anbe ST, Armstrong PW, Bates ER, Green LA, Hand M, et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2004; 44:671–719
[ix] Braunwald E, Antman EM, Beasley JW, Califf RM, Cheitlin MD, Hochman JS, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with unstable angina and non–ST-segment elevation myocardial infarction: summary article: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2002; 40:1366–1374. [x] Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, Daley J, Deedwania PC, Douglas JS, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with chronic stable angina: summary article: a report of the American College ofCardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2003; 107:149–158.
[xi] LGScompenso 2009Focused Update:ACCF/AHA Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2009;119:1977-2016.)
[xii] LG Cardiochirurgia ACC/AHA 2004 Guideline Update for Coronary Artery Bypass Graft Surgery. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery) Circulation 2004;110;e340-e437
[xiii] Wenger NK. Current status of cardiac rehabilitation. J Am Coll Cardiol 2008; 51: 1619-31.
[xiv] Joliffe JA, Rees K, Taylor RS, Thompson D, Oldridge N, Ebrahim S. Exercisebased rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database SystRev 2001; Issue 1 Art No: CD001800. DOI: 10.1002/14651858.CD001800
[xv] Piepoli MF, Davos C, Francis DP, Coats AJ, ExTraMATCH Collaborative. Exercise training meta-analysis of trials in patients with chronic heart failure(ExTraMATCH). BMJ 2004; 328:189–193.
[xvi] Linee guida nazionali su cardiologia riabilitativa e prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari. Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. Monaldi Arch Chest Dis 2006;66:81-116. [xvii] Urbinati S., Romanazzi S. Impostazione della prevenzione secondaria dopo infarto miocardico, G Ital Cardiol 2008; 9 (suppl 1/7): 49S-51S.
BIBLIOGRAFIA [1] Wenger NK, Froelicher ES, Smith LK et al. Cardiac Rehabilitation. Clinical practice guidelines. AHCPR and NHLBI, October 1995
[1] King ML, Williams MA, Fletcher GF et al. Medical director responsibilities for outpatient cardiac rehabilitation/secondary prevention programs: a scientific statement from the American Heart Association/American Association for Cardiovascular and pulmonary Rehabilitation. Circulation 2005; 112: 3354-60.
[1] Giannuzzi P, Saner H, Bjomstad H et al. for the WG on Cardiac Rehabilitation and Exercise Physiology of the European Society of Cardiology. Secondary prevention through cardiac rehabilitation. Eur Heart J 2003; 24: 1273-8.
[1] Piepoli MF, Corrà U, Benzer W et al. Secondary prevention through cardiac rehabilitation: from knowledge to implementation. A position paper from the Cardiac Rehabilitation Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2010 in press [1] Balady GJ, Williams MA, Ades PA et al. Core components of cardiac rehabilitation/secondary prevention programs: 2007 update. A scientific statement from AHA and AACPR. Circulation 2007; 115: 2675-82.
[1] Thomas RJ, King M, Lui K et al. AACVPR/ACC/AHA 2007 performance measures on cardiac rehabilitation for referral to and delivery of cardiac rehabilitation/ secondary prevention services. J Am Coll Cardiol 2007; 50: 1400-33.
[1] Griffo R, Urbinati S, Giannuzzi P et al. Linee guida nazionali su cardiologia riabilitativa e prevenzione secondaria: sommario esecutivo. G Ital Cardiol 2008; 9: 286-97.
[1] Antman EM, Anbe ST, Armstrong PW, Bates ER, Green LA, Hand M, et al. ACC/AHA guidelines for the management of patients with ST-elevation myocardial infarction: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2004; 44:671–719
[1] Braunwald E, Antman EM, Beasley JW, Califf RM, Cheitlin MD, Hochman JS, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with unstable angina and non–ST-segment elevation myocardial infarction: summary article: a report of the American College of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2002; 40:1366–1374. [1] Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, Daley J, Deedwania PC, Douglas JS, et al. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with chronic stable angina: summary article: a report of the American College ofCardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2003; 107:149–158.
[1] LGScompenso 2009Focused Update:ACCF/AHA Guidelines for the Diagnosis and Management of Heart Failure in Adults A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2009;119:1977-2016.)
[1] LG Cardiochirurgia ACC/AHA 2004 Guideline Update for Coronary Artery Bypass Graft Surgery. A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1999 Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery) Circulation 2004;110;e340-e437
[1] Wenger NK. Current status of cardiac rehabilitation. J Am Coll Cardiol 2008; 51: 1619-31.
[1] Joliffe JA, Rees K, Taylor RS, Thompson D, Oldridge N, Ebrahim S. Exercisebased rehabilitation for coronary heart disease. Cochrane Database SystRev 2001; Issue 1 Art No: CD001800. DOI: 10.1002/14651858.CD001800
[1] Piepoli MF, Davos C, Francis DP, Coats AJ, ExTraMATCH Collaborative. Exercise training meta-analysis of trials in patients with chronic heart failure(ExTraMATCH). BMJ 2004; 328:189–193.
[1] Linee guida nazionali su cardiologia riabilitativa e prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari. Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali. Monaldi Arch Chest Dis 2006;66:81-116. [1] Urbinati S., Romanazzi S. Impostazione della prevenzione secondaria dopo infarto miocardico, G Ital Cardiol 2008; 9 (suppl 1/7): 49S-51S.
|