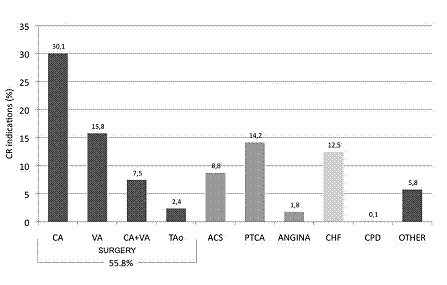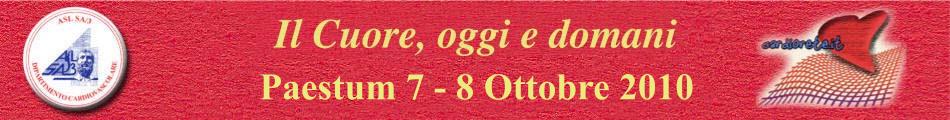
PROCESSO ALLA RIABILITAZIONE CARDIOVASCOLARE: I Fatti
Domenico Miceli UOSD Cardiologia Riabilitativa post – acuzie Dipartimento di Fisiopatologia e Riabilitazione Cardio-Pneumologica, AO Monaldi, Napoli
Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi nella cardiologia clinica e interventistica e nel trattamento delle fasi acute delle patologie cardiovascolari, e questo ha portato a una notevole diminuzione della mortalità. Per lo stesso motivo, è aumentata l’esigenza di un recupero fisico e psicologico dei pazienti, per un loro felice reinserimento nella società e, quando possibile, anche nel mondo del lavoro. Al tempo stesso, e come conseguenza, è cambiato anche il concetto di Cardiologia Riabilitativa (CR). Ancora negli anni ‘80 il percorso di riabilitazione faceva riferimento quasi esclusivamente alla componente dell’esercizio fisico, mentre oggi i programmi di recupero sono più articolati, coinvolgono più aspetti del problema e, soprattutto, in fase più precoce. Il programma di allenamento riabilitativo, che prima iniziava molto tardi, è stato modificato anche in seguito alla dimostrazione dell’efficacia di un percorso di allenamento fisico di entità moderata: le ristrette categorie di pazienti che venivano inseriti in questi programmi e che erano costituite quasi esclusivamente da pazienti reduci da un infarto miocardico non complicato, sono ora più ampie e diversificate al loro interno, comprendendo soggetti con infarto miocardico esteso, con disfunzione ventricolare sinistra e scompenso cardiaco cronico, operati di cardiochirurgia, portatori di device, pazienti con arteriopatia periferica, e i pazienti vengono avviati all’allenamento in una fase più precoce del percorso riabilitativo. È stata inoltre provata anche la sicurezza e la validità di programmi di training domiciliari, tuttora con scarsa diffusione e comunque destinati a gruppi di pazienti scelti. La CR si è evoluta anche per allinearsi al cambiamento avvenuto nel contesto cardiologico di riferimento. Oggi nei fatti la degenza in ospedale è molto più breve rispetto al passato, perché si concentra essenzialmente sulla risoluzione della fase acuta del problema: di conseguenza, la tendenza attuale è quella di delegare al programma di riabilitazione tutto l’insieme degli aspetti legati alla gestione del paziente, quali la valutazione funzionale e globale della sua condizione, il programma di esercizio fisico da seguire e l’opera informativa ed educativa, attraverso la pianificazione di un nuovo stile di vita che porti le necessarie modifiche alle precedenti abitudini del soggetto, realizzando quel link ormai ineludibile fra Riabilitazione Cardiologica e Prevenzione Secondaria. Le responsabilità del percorso di riabilitazione cardiologica sono perciò nuove e più numerose così come i suoi obiettivi sono più ampi e complessi. Eppure, nonostante il momento di grande vitalità e valorizzazione che la CR sta vivendo, le sfide che attualmente le vengono poste riguardano l’affermazione e la comprensione dell’importanza che essa riveste ai fini di un approccio davvero efficace alla malattia.
La programmazione sanitaria si sta sforzando di superare un modo
di pensare alle malattie cardiovascolari ormai obsoleto, che fa
sì che la maggior parte degli sforzi siano ancora rivolti alla
gestione della fase acuta della malattia.:infatti, sebbene
l’importanza del percorso di riabilitazione successivo alla fase
di emergenza sia stata finalmente riconosciuta, gli organismi
pubblici, designati a prendere decisioni in merito alle
caratteristiche specifiche delle CR, si trovano ancora in una
situazione di incertezza, che rende difficile stilare parametri
specifici di un'attività riabilitativa, nonché, di conseguenza,
valutare con precisione quelli esistenti. Intanto, un dato che è
possibile rilevare è la disparità che, al momento, ancora grava
sul sistema, non solo a livello territoriale, ma anche in
termini di requisiti desiderabili. A questo scopo è nato il
progetto ISYDE 2008 (Italian SurveY on carDiac
rEhabilitation-2008), uno studio d’osservazione longitudinale
del GICR-IACPR in grado di fornire dati accurati sulle strutture
di riabilitazione cardiologica del territorio nazionale dal
punto di vista dell’organizzazione e delle prestazioni offerte. Un percorso di CR ottimale comprende diverse attività, di cui le principali sono: l’esercizio fisico mirato, la correzione dello stile di vita attraverso la scelta di una nuova e corretta dieta alimentare, l’eliminazione del maggior numero possibile di fattori di rischio, l’attività di monitoraggio e il supporto psicologico necessario al paziente per affrontare la nuova condizione. Sarebbe perciò opportuno che tutte le persone reduci da un infarto o da un’angioplastica fossero indirizzate verso un ambulatorio riabilitativo. La fig.1 riporta le indicazioni alla Cardiologia Riabilitativa in base ai dati ISYDE 2008.
Fig.1: indicazioni alla Cardiologia Riabilitativa – dati progetto ISYDE 2008 – GICR-IACPR Monaldi Arch Chest Dis 2008;70:e1-e31
Le Linee Guida Nazionali sottolineano come “la combinazione di un adeguato monitoraggio e intervento clinico, un programma di esercizio fisico e di interventi strutturati educativi e psicologici rappresentino la forma più efficace di CR”. I programmi di CR includono le seguenti componenti: · assistenza clinica volta alla stabilizzazione; · valutazione del rischio cardiovascolare globale; · identificazione di obiettivi specifici per la riduzione di ciascun fattore di rischio; · formulazione di un piano di trattamento individuale con: a. interventi terapeutici finalizzati alla riduzione del rischio; b. programmi educativi strutturati, dedicati e finalizzati a un effettivo cambiamento dello stile di vita (abolizione del fumo, dieta appropriata, controllo del peso, benessere psicologico); c. prescrizione di un programma di attività fisica finalizzato a ridurre le disabilità conseguenti alla cardiopatia, migliorare la capacità funzionale e favorire il reinserimento sociale e lavorativo; · interventi di mantenimento allo scopo di consolidare i risultati ottenuti e favorire l’aderenza a lungo termine, garantendo la continuità assistenziale. Queste componenti si integrano nel progetto riabilitativo individuale che identifica gli obiettivi da raggiungere nel singolo paziente con gli strumenti a disposizione e nell’intervallo di tempo in cui si prevede di poter effettuare l’intervento. Gli obiettivi nel breve termine sono: · perseguire la stabilità clinica; · limitare le conseguenze fisiologiche e psicologiche della malattia cardiovascolare; · migliorare globalmente la capacità funzionale e incidere così favorevolmente sul grado di autonomia, indipendenza e, quindi, sulla qualità della vita. Gli obiettivi nel medio e lungo termine sono: · ridurre il rischio di successivi eventi cardiovascolari; · ritardare la progressione del processo aterosclerotico e della cardiopatia sottostante e il deterioramento clinico; · ridurre morbilità e mortalità. È importante arrivare alla consapevolezza dell’importanza ora rivestita dalla riabilitazione all’interno del percorso di cura, in modo che i pazienti possano sapere cosa aspettarsi e cosa richiedere. Gli operatori di settore, da parte loro, si interrogano per capire se la CR sia pronta per il ruolo che le viene affidato e studiano la situazione per individuare con precisione quali siano i suoi punti di forza e di debolezza.
Lo studio ISYDE-2008, che ha censito le strutture di
riabilitazione cardiologica nel nostro paese, ha identificato il
paziente tipo da indirizzare al percorso di riabilitazione: si
tratta prevalentemente di un paziente anziano (dato conforme
alle statistiche che segnalano l’alzarsi dell’età media della
popolazione) che, nei due terzi dei casi, accede alla
riabilitazione dopo un intervento chirurgico per problemi
cardiaci, in particolare, nel 30% dei casi, dopo un intervento
coronarico. Per inciso, un dato che è emerso segnala che gli
uomini accedono alle strutture riabilitative molto più delle
donne (il 63% contro 27%). Questo dato è in linea con quanto
registrato in altre nazioni, per esempio gli Stati Uniti, e
secondo gli esperti si spiega facilmente con il fatto che le
donne si ammalano in età più avanzata rispetto agli uomini,
rendendole soggetti meno privilegiati nell’accesso ai programmi
di riabilitazione. In linea di continuità rispetto gli obiettivi dell' Italian Survey on Cardiac Rehabilitation ISYDE-2008 condotto dal GICR-IACPR ed in coerenza con gli action-plans sollecitati dalla Società Europea di Cardiologia sulla implementazione delle linee guida di prevenzione delle malattie cardiovascolari, il GICR ha ritenuto utile predisporre una survey che consenta di raccogliere in modo sistematico e accurato una serie di informazioni che permettano di definire nel "mondo reale" le caratteristiche dei pazienti con cardiopatia ischemica sottoposti a rivascolarizzazione coronarica, che vengono avviati a programmi di CR, quali interventi e trattamenti vengano attuati, e di verificare nel breve e medio termine sia l'aderenza a tali trattamenti che il perseguimento dei target raccomandati e il rapporto tra questi e gli eventi e i consumi di risorse sanitarie.
Il progetto ICAROS (Italian Survey on CArdiac RehanilitatiOn and
Secondary prevention after Cardiac Revascularization) si
configura come una survey prospettica, longitudinale e
multicentrica, con raccolta dati web-based, il cui
disegno risponde allo scopo di descrivere puntualmente nella
realtà cardiologica italiana, attraverso un numero
rappresentativo di Centri di CR afferenti al network nazionale
del GICR-IACPR, le caratteristiche, il contenuto e gli effetti
nel medio termine dei programmi di CR degenziali o ambulatoriali
offerti a pazienti dopo un intervento chirurgico e percutaneo di
rivascolarizzazione coronarica. Gli obiettivi primari dello
studio, che concluderà il follow-up al termine del 2010, sono: CONCLUSIONI 1) La CR è stata definita una pillola a basso costo che può ridurre la mortalità post-IMA fino al 25%: essa è dunque ampiamente riconosciuta come il modello standard per il trattamento globale del paziente cardiopatico in fase post-acuta e costituisce il modello più efficace e cost-effective per la implementazione di una strategia di prevenzione secondaria adeguata sul medio-lungo termine.
2)Analizzando i dati SDO Ministero della Salute degli ultimi
anni si rilevano oltre 90.000 pazienti dimessi dopo infarto
miocardico acuto, circa 130.000 dimessi dopo angioplastica
coronarica, 140.000 pazienti dimessi dopo episodio di scompenso
cardiaco, 45.000 pazienti dimessi dopo chirurgia cardiaca, per
un totale di circa 450.000 pazienti/anno candidabili a CR. 4) Non è attualmente noto in Italia se i pazienti ammessi a programmi di CR ricevano trattamenti coerenti rispetto alle attuali Linee Guida e vengano dimessi nelle condizioni più adeguate per ottenere una efficace prevenzione secondaria a breve-medio termine. 5) Risultano ancora controverse le informazioni relative all'efficacia e alla sostenibilità nel breve e medio termine di vari modelli assistenziali post riabilitazione intensiva, da quello spot in post-acuzie e svincolato da un successivo programma di rinforzo nel tempo, a quello con periodici controlli cardiologici a cura del centro di riabilitazione.
|