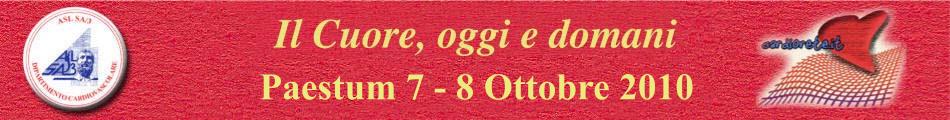
IL TRATTAMENTO DELL’ANEURISMA DELL’AORTA ADDOMINALE
Eugenio Meucci, Fernando Petrosino, Luigi Meucci, Salvatore De Vivo, Alessandro Luongo, Adriana Perziano, Luigi Gallo*, Rocco De Leo*
Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare *Unità Operativa Complessa di Anestesia e Sala Operatoria P.O. S.Luca – Vallo della Lucania – ASL SALERNO
L’aneurisma dell’aorta addominale, definendo come tale una dilatazione dell’aorta con un diametro > 3 cm (>1,5-2 volte il valore di normalità), è una patologia multifattoriale, più frequente in soggetti fumatori, dislipidemici o ipertesi, che può presentare una predisposizione familiare e che colpisce globalmente il 5-7% degli uomini e l’1% delle donne. La presenza di un aneurisma dell’aorta addominale identifica una popolazione a più elevato rischio di rottura e di altri eventi cardiovascolari quali l’infarto del miocardio, l’ictus e l’ischemia degli arti inferiori. Il rischio di rottura annuo di un aneurisma dell’aorta addominale è direttamente proporzionale al suo diametro ed è maggiore in caso di espansione rapida e nel sesso femminile. La valutazione del rischio di rottura dell’aneurisma, del rischio peri-operatorio e dei risultati chirurgici immediati ed a distanza condiziona, naturalmente, la scelta di un trattamento realizzato nell’intento di prevenire la rottura dell’aneurisma e la mortalità ad esso correlata. Tale scelta è indirizzata attualmente dalle linee guida condivise dalle Società Internazionali e basate sui dati pubblicati in letteratura ed in particolare, per le indicazioni generiche all’intervento chirurgico, prevalentemente sui trial realizzati sugli aneurismi di piccolo calibro: United Kingdom Small Aneurysm Trial (UKSAT) e Aneurysm Detection and Management (ADAM). La SICVE (Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare) raccomanda difatti di non trattare gli aneurismi sottorenali o juxtarenali asintomatici di diametro inferiore a 50 mm nei maschi e a 45 mm nelle donne (raccomandazione di Grado C, livello I). Analogamente le linee guida della SVS (Society for Vascular Surgery) e dell’ACC/AHA (American College of Cardiologist/American Heart Association) raccomandano il monitoraggio per gli aneurismi fusiformi, asintomatici di diametro inferiore ai 40 mm ed il trattamento chirurgico per gli aneurismi fusiformi, asintomatici, di diametro superiore a 54 mm in pazienti in buone condizioni generali. Il trattamento in elezione è, ancora, raccomandato per AAA sacciformi o con elementi morfologici che suggeriscano un’evolutività (incremento diametro>1cm/anno, dissecazione del trombo, presenza di blister, etc.) e quindi un rischio di rottura, oltre che naturalmente negli aneurismi dolorosi. Nei pazienti portatori di aneurismi di diametro compreso tra 40 e 54 mm l’eventuale trattamento non garantisce quindi un incremento significativo della sopravvivenza, come dimostrato dai già citati trial UKSTA ed ADAM. Anche i trial condotti nell’intento di documentare un efficacia del trattamento endovascolare (EVAR: endovascular aneurysm repair) negli aneurismi di piccole dimensioni (CAESAR trial e PIVOTAL trial) non hanno mostrato risultati definitivi a tale riguardo. La posizione maggiormente condivisa suggerisce il monitoraggio ed il trattamento selettivo nei pazienti anziani, di sesso maschile, con severe comorbidità associate ed il trattamento dei pazienti giovani, sani specie se di sesso femminile e con diametri tra 50 e 54 mm. Altro argomento oggetto di notevoli controversie è rappresentato dall’impiego di un trattamento chirurgico aperto o endovascolare, scelta che si basa su una valutazione il più delle volte complessa e che richiede un studio meticoloso del singolo paziente e dell’aneurisma di cui è portatore. Escludiamo da questa dicotomia gli aneurismi pararenali nei quali le arterie renali sono adiacenti al colletto prossimale dell’aneurisma (aneurismi iuxtarenali) o partono dalla sacca aneurismatica (aneurismi soprarenali) imponendo, pertanto, l’impiego di una soluzione chirurgica open salvo ricorrere, in pochi centri ad elevati volumi, all’impianto delle dispendiose protesi fenestrate o alla realizzazione di una “chimney technique” i cui risultati a medio-lungo termine sono, peraltro, ancora da validare. Il dilemma endovascolare o open resta, pertanto, aperto per gli aneurismi sottorenali nei quali nella pratica corrente l’impiego della soluzione endovascolare acquisisce sempre maggior diffusione in virtù dell’interesse sollevato dalla tecnica meno invasiva, caratterizzata da tassi di morbi-mortalità più contenuti, da una degenza più breve ed, in ultima analisi, da una migliore accettazione da parte del paziente. Ma quali sono i risultati a lungo termine delle due tecniche osservati nei trial comparativi? Nello studio EVAR 1 i risultati a 10 anni hanno mostrato che gli iniziali vantaggi dell’EVAR giustificati per la bassa mortalità operatoria (circa 1/3 rispetto alla chirurgia open), sono vanificati a 6 anni di follow-up a causa dell’elevato numero di rotture dell’aneurisma a distanza dal trattamento endovascolare, contro nessuna rottura dopo chirurgia open. Anche l’indennità da complicanze e reinterventi a distanza è risultata nettamente a favore della chirurgia open, con differenze statisticamente significative. Analogamente, i risultati a 6 anni del DREAM non hanno mostrato nessuna differenza significativa in termini di sopravvivenza a distanza, laddove a 4 anni di follow-up un aumento allarmante di reinterventi si è manifestato dopo EVAR. Più recentemente (2002-2008) il trial americano OVER ha randomizzato 881 pazienti con un aneurisma di diametro superiore a 5 cm, 444 a un trattamento endovascolare e 437 a una chirurgia open. I risultati ad interim, a un follow-up di quasi 2 anni (1.8) hanno mostrato una mortalità peri-operatoria significativamente più elevata dopo chirurgia open, in entrambi i casi più bassa che nei trials europei, laddove nel corso del follow-up la mortalità dei due gruppi è stata sovrapponibile (6.1% vs 6.6% ; p= .74), senza alcuna differenza significativa in termini di mortalità globale a due anni (7.0% vs 9.8% ; p= .13). Nessuna differenza è stata osservata in termini di fallimento della procedura, di reinterventi a distanza, di ricoveri iterativi per la patologia aneurismatica, o di morbidità significativa a 1 anno. Dei 61 reinterventi dopo EVAR, circa 2/3 (42) sono stati realizzati per via endovascolare e dei 55 reinterventi dopo chirurgia open oltre la metà (30) sono stati dei laparoceli, 7 i reinterventi sull’innesto aortico. Non è stata osservata nessuna differenza relativamente alla qualità di vita e alla funzione erettile del corso dei due anni di follow-up. Di particolare interesse sono i risultati pubblicati recentemente relativi al trattamento chirurgico convenzionale ovvero endoluminale di 45660 pazienti beneficiari del sistema assicurativo statunitense Medicare dal 2000 al 2004 e seguiti fino al 2005 che, analogamente ai trials europei, hanno dimostrato una mortalità inferiore dopo trattamento endovascolare (1.2% vs 4.8%), con delle differenze tanto più significative quanto più è avanzata l’età dei pazienti, del 2.1% al di sotto di 70 anni e dell’8.5% al di sopra di 80 anni. Analogamente ai trials europei, l’andamento delle curve di sopravvivenza in funzione dell’ età ha mostrato una mortalità a distanza simile nelle due coorti di pazienti ma la convergenza delle due curve si manifesta solo a distanza di 3 anni e sempre più tardivamente quanto più è avanzata l’età dei pazienti. Il rischio di rottura dell’aneurisma a distanza del trattamento endovascolare è stato solo dell’1.8%, come anche relativamente modesto il numero di reinterventi relativi alla patologia aneurismatica (9%), comunque superiore a quello del trattamento chirurgico convenzionale. Complessivamente, in base a tali risultati la mortalità e le complicanze precoci del trattamento endovascolare sono risultate inferiori rispetto al trattamento chirurgico convenzionale. Le curve di sopravvivenza sono state più durature e favorevoli al trattamento endovascolare nei pazienti in età avanzata. E’ comunque indispensabile, nel selezionare il trattamento idoneo per il singolo paziente, un’attenta analisi sia del contesto clinico, in particolare delle comorbidità che condizionano il rischio (specie cardiologico) di una chirurgia open, che delle caratteristiche anatomiche dell’aneurisma, che condizionano le possibilità o meno di un trattamento endovascolare, in termini di fattibilità e di risultati a distanza. La scelta risulterà, infine, fortemente condizionata sia dalle preferenze del paziente, che dall’orientamento del chirurgo. La percentuale di interventi endovascolari ha, comunque, raggiunto in numerosi centri ad elevato volume valori talmente elevati (>80% del totale) da lasciare intendere che l’unico elemento discriminante la scelta resta per molti il solo rispetto dei requisiti anatomici previsti per le diverse endoprotesi, oggetto spesso, peraltro, di interpretazioni soggettive e di tentativi di adattare la soluzione endovascolare ad anatomie sempre più complesse. A conferma di ciò basta citare le linee guida della SICVE che pongono, al punto 4, l’indicazione all’EVAR sulla scorta solo del rispetto delle condizioni anatomiche e tecniche (Raccomandazione di grado A, livello III), non mettendo in discussione, come elementi vincolanti la scelta, il rischio operatorio del paziente o la sua età. Al contrario l’SVS suggerisce anche elementi clinici di valutazione all’EVAR quali la coesistenza di una patologia coronarica e soprattutto il recente impianto di stent coronarici medicati che comporti la necessità di una doppia antiaggregazione. Le linee guida dell’SVS allargano le indicazioni all’EVAR anche ai casi compassionevoli esprimendo addirittura una raccomandazione, sia pure con una bassa qualità dell’evidenza, per i pazienti “unfit” per il trattamento chirurgico open. Analogamente le linee guida dell’ACC-AHA suggeriscono il trattamento open nei pazienti a medio o basso rischio perioperatorio, (Livello di evidenza B), riservando ai pazienti ad alto rischio per comorbidità cardiopolmonari o di altra natura il trattamento endovascolare che può, però, a giudizio dell’ACC-AHA, essere preso in considerazione anche nei pazienti a basso rischio (Livello dell’evidenza B). Più restrittive sono le indicazioni espresse dall’Agence Francaise de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPRS) che elencano le condizioni di rischio nelle quali configurare un trattamento endovascolare includendo tra le altre la presenza di un addome ostile, di ascite e/o segni ipertensione portale. Le stesse linee guida sottolineano l’importanza del rispetto nel caso di un trattamento endovascolare dei criteri anatomici e delle controindicazioni delle singole protesi elemento questo che condiziona in maniera rilevante insuccessi precoci e risultati a distanza del trattamento chirurgico. Le linee guida NICE del 2009 puntualizzano prima di tutto l’indicazione all’intervento chirurgico, indipendentemente dalla tecnica, la cui scelta deve essere frutto della discussione tra chirurgo e paziente sulla base di dati oggettivi. Un’altra raccomandazione espressa riguarda il possesso di adeguati requisiti e di esperienza da parte della struttura e degli operatori coinvolti nel trattamento. Relativamente al contesto clinico del paziente, la stratificazione del rischio cardiologico è senza dubbio più interessante della definizione del rischio anestesiologico secondo la classificazione ASA, abbandonata nella letteratura più recente tra i fattori prognostici che condizionano il rischio operatorio. Difatti, quale che sia l’opzione terapeutica, la stratificazione del rischio cardiologico è cruciale, secondo le linee guida del 2007 dell’American College of Cardiology e dell’American Heart Association, che hanno identificato tra i fattori di rischio una pregressa cardiopatia ischemica, uno scompenso cardiaco, una patologia cerebrovascolare, il diabete e un’ insufficienza renale. Al di fuori del contesto dell’urgenza e in assenza di una sintomatologia cardiaca, sia in caso di chirurgia open che di EVAR, nel caso di un paziente che abbia una buona capacità funzionale (superiore a 4 equivalenti metabolici-MET), si può procedere direttamente all’intervento. Se tale capacità funzionale è <4 MET ovvero sconosciuta : · in presenza di tre o più fattori di rischio si deve procedere a un test non invasivo della riserva coronarica, un ecostress con dobutamina o una scintigrafia miocardica e, se indicato, a una coronarografia; · se i fattori di rischio sono uno o due è indicato un controllo della frequenza cardiaca con beta-bloccanti e eventualmente un test non invasivo. Per una valutazione oggettiva del rischio peri-operatorio globale sono stati introdotti diversi modelli predittivi che, valutando la presenza di diversi fattori prognostici il cui peso viene espresso numericamente, hanno identificato sottogruppi di pazienti a basso o alto rischio in caso di chirurgia open. I più efficaci sono il Glasgow Aneurysm Score (adottao dalla SICVE), il Leiden Score e il Comorbidity Severity Score (adottato dalla SVS). In una recente pubblicazione (Faizer. JVS 2007), l’applicazione di tali modelli al database relativo a 558 interventi open e 304 EVAR eseguiti in 5 anni ha consentito di identificare per ciascuno dei modelli un cut point al di sotto dei quali i risultati della chirurgia open sono stati eccellenti, senza nessuna differenza significativa tra chirurgia open e EVAR in termini di mortalità peri-operatoria. E’ possibile, pertanto, identificare un gruppo di pazienti per i quali l’interesse principale dell’EVAR, una mortalità operatoria di tre volte inferiore alla chirurgia open nei trials randomizzati, viene vanificato. Al di sopra dei cut point la mortalità della chirurgia open è stata, viceversa, significativamente più elevata rispetto all’EVAR, individuando un gruppo di pazienti per i quali l’EVAR dimostra tutto il suo interesse. Nei pazienti ad elevato rischio peri-operatorio sarebbe peraltro possibile contemplare anche l’opzione astensione da qualunque trattamento. I risultati a 10 anni dello studio EVAR 2 hanno dimostrato però che, pur non essendovi alcuna differenza significativa in termini di mortalità globale e pur essendo le aspettative di vita di questi pazienti molto modeste, un trattamento endoluminale consente di ridurre significativamente la mortalità correlata all’aneurisma. A condizione, pertanto, di verificare la compatibilità anatomica (assoluta o relativa) al trattamento endovascolare, l’EVAR trova quindi tutto il suo interesse in un paziente ad alto rischio che debba convivere quotidianamente con un rischio di rottura di un aneurisma di grosso diametro, tenuto conto del rischio elevato di una chirurgia open e delle ridotte aspettative di vita del paziente, che riducono il rischio relativo di complicanze a distanza del trattamento endoluminale. In un contesto di equivalenza tra le due opzioni terapeutiche, rischio basso di una chirurgia open e morfologia dell’ aneurisma favorevole a un trattamento endovascolare, la scelta tra chirurgia endovascolare e EVAR rimane, anche alla luce dei dati presentati, controversa, considerato che l’EVAR si beneficia di una morbi-mortalità peri-operatoria minore, di una degenza più breve, non richiede stazionamento in ICU, ma comporta maggiori costi, richiede una sorveglianza costante, espone a un maggior numero di reinterventi e, soprattutto, di rotture dell’aneurisma che vanifica la ridotta mortalità operatoria e rende equivalente la mortalità a distanza delle due procedure, sia globale che correlata alla patologia aneurismatica.
CONCLUSIONI
Resta difficile formulare delle conclusioni su un argomento così complesso e controverso. Le raccomandazioni che emergono dalla nostra trattazione basata sull’analisi della letteratura sono le seguenti: · la scelta tra le diverse modalità terapeutiche deve basarsi sull’età ma soprattutto sulle aspettative di vita del paziente, sulle caratteristiche anatomiche dell’ aneurisma, e sul rischio operatorio del paziente; · un trattamento chirurgico convenzionale è indicato nei pazienti più giovani, con minori comorbidità, soprattutto in presenza di un’anatomia complessa; · un trattamento chirurgico endovascolare è indicato nei pazienti in età avanzata, con maggiori comorbidità, in presenza di un’ anatomia favorevole. Tali raccomandazioni sono chiaramente generiche, non fosse altro per la definizione di “rischio operatorio basso o elevato” difficile da precisare, e pertanto la scelta non può prescindere dalla valutazione del singolo paziente. Tale valutazione rinvia al ruolo centrale del chirurgo e alle sua conoscenza della storia naturale della malattia e del suo rischio evolutivo, come anche delle aspettative di vita del paziente. Quando si opti per un trattamento open, essenziale è la valutazione del rischio operatorio del singolo paziente, operata dal chirurgo con il supporto di altri specialisti (cardiologo, pneumologo, anestesista), che non possono però sostituirsi a lui nella definizione di operabilità. Quando si opti per un trattamento endoluminale, determinante è la valutazione dell’anatomia dell’AAA che condiziona la fattibilità e la complessità del trattamento e quindi anche i risultati immediati e a distanza. Parte fondamentale del trattamento endovascolare è difatti lo studio morfologico preoperatorio del singolo caso propedeutico alla scelta del device, che l’operatore deve realizzare in autonomia supportato, arricchito, ma non limitato dal parere del radiologo vascolare o degli specialisti di prodotto, con cui può confrontare le proprie valutazioni ma non delegarle a loro. Infine l’operatore deve avere le capacità di fornire le informazioni che il paziente ha il diritto di ricevere per poter operare la sua scelta, assumendosi nel contempo la responsabilità del trattamento da lui proposto sulla base delle proprie più profonde convinzioni etiche.
BIBLIOGRAFIA Chaikof EL, Brewster DC, Dalman RL et al. Society for Vascular Surgery. The care of patients with an abdominal aortic aneurysm: the Society for Vascular Surgery practice guidelines. J Vasc Surg 2009; 50 (4 Suppl):S2-49. ACC/AHA Guidelines for the Management of patients with Peripheral Arterial Disease (lower extremitiy, renal mesenteric and abdominal aortic): a collaborative report from the American Association for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Intervention, Society for VAscula Medicin and Biology,Society of International Radiology and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines. Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR et al. J Vasc Interv Radiol 2006;17:1383-97. Linee guida SICVE www.sicve.it
Faizer R, DeRose G, Lawlor DK et al.s
Objective scoring systems of medical risk: A clinical tool for
selecting patients for open or endovascular abdominal aortic
aneurysm repair. Leurs LJ, Buth J, Harris PL, Blankensteijn J Impact of study design on outcome after endovascular abdominal aortic aneurysm repair. A comparison between the randomized controlled DREAM-trial and the observational EUROSTAR-registry. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007;33:172-6. NICE technology appraisal guidance 167Endovascular stent-graft for the treatment of abdominal aortic aneurysm. www.nice.org.uk/TA167.Agence Francaise de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPRS). Recommendation d’utilisation des endoprothese aortiques pour le traitment endovasculaire des aneurisms de l’aorte abdominal sous-renale. J Mal Vasc 2003;28:301. Lederle FA, Johnson GR, Wilson SE et al: The aneurism detection and management stuty screening program validation cohort and final results: Aneurysm Detectione and Management Veterans Affairrs Cooperative Study Investigators. Rch Intern Med 2000;160:1425-30. United Kingdom small aneurysm trial participants. Long –term outcomes of immediate repair compared with surveillance of small adominal aortic aneurysm. N Engl J Med 2002;346:1445-52. Cao P, CAESAR trial collaborators. Comparison of surveillance vs Aortic Endografting for Small Aneurysm Repair. (CAESAR) trial study progress. Eur J Vasc Endovasc Surg 2005;30:241-51 Ouriel K. The PIVOTAL study: a randomized comparison of endovascular repair versus surveillance in patients with smaller abdominal aortic aneurysm. J Vasc Surg 2009; 49:266-9. The EVAR trial participants. Comparison of endovascular aneurysm repair with open repair in patients with abdominal aortic aneurysm (EVAR trial 1), 30-day operative mortality results: randomized controlled trial. Lancet 2004; 364: 843–48 Endovascular versus Open Repair of Abdominal Aortic Aneurysm. The United Kingdom EVAR Trial Investigators. The New England Journal of Medicine 10.1056/nejmoa0909305 nejm.org EVAR Trial participants. Endovascular aneurysm repair and outcome in patients unfit for open repair of abdominal aortic aneurysm. (EVAR trial 2). Randomized controlled trial. Lancet 2005;365:2187-92. Baas AF, Janssen KJ, Prinssen M, Buskens E, Blankensteijn JD The Glasgow Aneurysm Score as a tool to predict 30-day and 2-year mortality in the patients from the Dutch Randomized Endovascular Aneurysm Management trial. J Vasc Surg. 2008;47:277-81. Beck AW, Goodney PP, Nolan BW, Likosky DS, Eldrup-Jorgensen J, Cronenwett JL; Vascular Study Group of Northern New England Predicting 1-year mortality after elective abdominal aortic aneurysm repair. J Vasc Surg. 2009;49:838-43. Giles KA, Schermerhorn ML, O'Malley AJ, Cotterill P, Jhaveri A, Pomposelli FB, Landon BE. Risk prediction for perioperative mortality of endovascular vs open repair of abdominal aortic aneurysms using the Medicare population. J Vasc Surg. 2009;50:256-62.
|