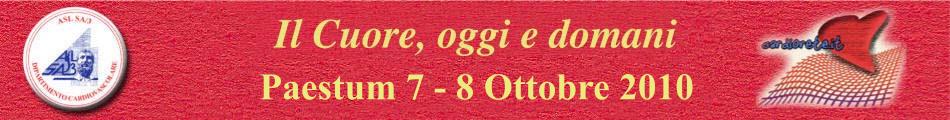
LA SINDROME DI BRUGADA. Valentino Ducceschi, Michele Santoro, Filippo Gatto, Antonio Aloia, Luigi Petraglia, Ilaria Caso, Roberto Viceconti, Giovanni Gregorio. U.O. UTIC – Cardiologia. Ospedale San Luca, Vallo della Lucania, ASL Salerno
Descritta per la prima volta come nuova entità clinica nel 1992, la sindrome di Brugada appare in forma isolata o a trasmissione ereditaria autosomica dominante come un disturbo essenzialmente “elettrico” in cuori strutturalmente sani, comportando un’ elevata incidenza di sincope e/o morte improvvisa, spesso a carattere familiare (1-5). Trattasi nella maggioranza dei casi di una mutazione del gene SCN5A che codifica per la subunità alfa del canale del sodio, ma sono riportate altre mutazioni riguardanti i canali del calcio e del potassio con simile aspetto fenotipico. Peraltro, va ricordato che solo nel 20% dei pz con sindrome di Brugada accertata l’ analisi genetica dà riscontri positivi. Le suddette anomalie genetiche comportano una disomogeneità dei periodi refrattari dell’ endocardio e dell’ epicardio ventricolare dx, che predisporrebbe a meccanismi di rientro “funzionali” indotti da extrasistoli. Fattori precipitanti gli eventi aritmici sarebbero il sonno, l’ ipertermia, le diselettrolitemie etc. La diagnosi sospetta è posta dopo un attento esame elettrocardiografico per il riscontro di un tipico aspetto simil blocco di branca dx con tratto ST sopraslivellato di almeno 2 mm e convesso verso l’ alto seguito da onda T negativa in almeno una delle precordiali da V1 a V3. Tale quadro, definito “Pattern Tipo 1”, può essere manifesto, se spontaneamente presente, od occulto, se slatentizzato da farmaci antiaritmici di classe I o da beta-bloccanti , e va ricercato con cura anche registrando le derivazioni precordiali al secondo o terzo spazio intercostale. Esistono altri due Pattern “simil Brugada”, il Tipo 2 con tratto ST sempre sopraslivellato di almeno 2 mm ma concavo verso l’ alto, seguito da onda T positiva ed il Tipo 3, con tratto ST sopraslivelllato di non più di 1 mm, concavo o convesso, sempre nelle stesse derivazioni. Diversamente da quanto sancito nel primo “Consensus Report” del 2002, attualmente i Pattern Tipo 2 e 3 non hanno valore diagnostico se non si trasformano nel Tipo 1 dopo controlli ecgrafici seriati o dopo test farmacologico per lo più con flecainide; tale approfondimento va ovviamente riservato solo ai pz sintomatici o con storia familiare di sincope e/o morte improvvisa. Pertanto possiamo concludere che la diagnosi di sindrome di Brugada si deve basare sul riscontro del Pattern Tipo 1 all’ ECG, sulla sintomaticità del pz o sull’ inducibilità di tachiaritmie ventricolari maligne allo studio elettrofisiologico, meglio ancora se associati a storia familiare di morte improvvisa. L’ opinione corrente oggi, stando a quanto stabilito dall’ ultimo “Consensus Report”, è quello di riservare l’ impianto dell’ AICD in prima istanza ai pz con pattern tipo 1 spontaneo o slatentizzato con anamnesi di arresto cardiaco. I pz sintomatici per sincope e con storia familiare di morte improvvisa, specie se mostrano inducibilità di tachiaritmie ventricolari sostenute allo studio elettrofisiologico, vanno sicuramente anch’ essi sottoposti ad impianto di AICD. Controverso è invece il caso dei pz asintomatici con pattern Tipo 1: secondo la maggioranza degli esperti andrebbero indirizzati allo studio elettrofisiologico solo i pz con storia familiare di morte improvvisa, ed in questo caso ai fini decisionali sarebbe dirimente l’ eventuale inducibilità di aritmie maligne. I pz asintomatici con Pattern Tipo 1, senza storia familiare di morte improvvisa, invece, andrebbero soltanto tenuti in follow-up.L’ eventuale efficacia di una terapia farmacologica non è stata adeguatamente approfondita con studi multicentrici dato l’ alto rischio connesso col quadro clinico e le conseguenti implicazioni medico legali, ma alcune segnalazioni assegnerebbero un ruolo profilattico nei confonti delle recidive aritmiche alla chinidina. Da ultimo, è doveroso sottolineare come alcuni pz altamente sintomatici vadano incontro a vere e proprie “tempeste aritmiche” scatenate spesso da fattori precipitanti quali sindromi febbrili, disionie, assunzione di farmaci particolari. Tali eventi vanno trattati con infusione endovenosa rapida di amine simpatico mimetiche come l’ isoproterenolo, che contrasterebbe il meccanismo elettrogenetico della tempesta aritmica: sfortunatamente tali quadri si osservano solo nei pz già sottoposti ad impianto di AICD, perché nei restanti casi sono purtroppo rapidamente mortali. Per i pz con sindrome di Brugada con frequenti interventi appropriati dell’ AICD, non va sottovalutata la possibilità di ablazione dei foci ectopici ventricolari “trigger” che si rinvengono nella maggioranza dei casi nell’ infundibulo ventricolare dx o nelle fibre del sistema di Purkinjie.
bibliografia !) Brugada P. et al. Right bundle branch block, persistent ST segment elevation and sudden cardiac death: a distinct clinical and electrocardiographic syndrome: a multi center report. JACC 1992; 20: 1391-1396. 2) Priori S. G. et al. Natural history of Brugada syndrome: insights for risk stratification and management. Circulation 2002; 105: 1342-1347. 3) Giustetto et al. Risk stratification of the patients with Brugada typee lectrocariogram: a community based prospective study. Europace 2009; 11: 507-513. 4) Sarkozy A. et al. Long term follow up mof primary prophylactic implantable cardioverter-defibrillator therapy in Brugada syndrome. Eur. Heart J. 2007; 28: 334-344. 5) Probst V. Long term prognosis of patients diagnosed with Brugada syndrome: results from the FINGER Brugada syndrome registry. Circulation 2010; 121: 635-643.
|