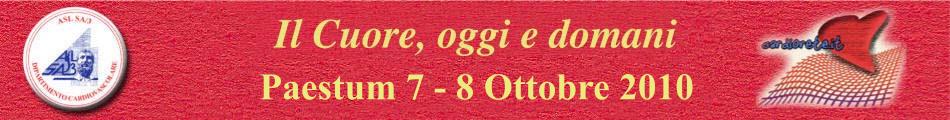
|
La Gestione medica della Endocardite Infettia
Pio Caso, Luigi Nunziata*,Maria Macrino*, Massimo Cavallaro, Raffaele Calabrò* UOC di Cardiologia, AO Monaldi ,Napoli *Cattedra di Cardiologia, Seconda Università di Napoli, A.O. Monaldi, Napoli
Introduzione L’endocardite infettiva (EI) rappresenta una patologia di notevole impegno medico associata a significativa morbilità e mortalità che richiede una diagnosi il più possibile precoce ed una terapia mirata. Le caratteristiche epidemiologiche di tale malattia sono variate nel tempo, soprattutto in relazione all’allungamento della vita media, alla maggiore incidenza di abusi di droghe e di interventi di protesi valvolari; attualmente negli Stati Uniti e nell’Europa Occidentale l’incidenza di malattia nella comunità è di 1.7-6.2 casi per 100000 abitanti all’anno 1-2; gli uomini sono affetti in misura maggiore rispetto alle donne (rapporto di 1.7:1) e la fascia di età più colpita è quella compresa tra 47 e 69 anni 2-3. Nei pazienti, invece, che fanno uso di droghe per via endovenosa, l’incidenza stimata è di 150-2000 casi ogni 100000 abitanti all’anno 4. Importanti progressi negli ultimi 50 anni, sono stati conseguiti in termini di diagnosi (in primo luogo l’ecocardiografia) e di trattamento dell’ endocardite infettiva (miglioramenti nel trattamento antibiotico e soprattutto la chirurgia). Tali cambiamenti hanno portato a ridurre la mortalità e le complicazioni durante la fase attiva della malattia ma anche a modifiche radicali nel decorso clinico e la storia naturale della malattia. Anche i microrganismi responsabili sono cambiati, con aumentata incidenza di EI Stafilococciche e nuovi agenti patogeni come Coxiella burnetii, Bartonella spp, etc. Tuttavia, questa infezione ha , ancora ,alti tassi di morbilità e mortalità in diversi sottogruppi di pazienti. Diversi studi hanno mostrato che l'endocardite infettiva è una malattia con una cattiva prognosi a breve, medio ed a lungo termine. Una buona risposta iniziale al trattamento medico non deve indurre a considerare il paziente come a basso rischio, ma bisogna sempre procedere ad uno stretto follow-up5.
Definizione L’EI è un’infezione endovascolare delle strutture cardiache (valvole native, endocardio atriale e ventricolare) o di corpi estranei intracardiaci (protesi valvolari, cateteri di pacemaker e defibrillatori intracardiaci, condotti creati chirurgicamente) a contatto con il flusso sanguigno, e coinvolgente anche i grossi vasi intratoracici (condizione che si può verificare nella pervietà del dotto arterioso, negli shunt artero-venosi, nella coartazione aortica).
Le alterazioni iniziali dell’EI sono rappresentate da vegetazioni di dimensioni variabili che contengono piastrine, eritrociti, fibrina, cellule infiammatorie e microrganismi. Tuttavia la distruzione (per esempio di una valvola), l’ulcerazione, la formazione di ascessi possono essere le prime alterazioni rilevate all’esame ecocardiografico6.
Prevenzione L'endocardite infettiva, sebbene patologia non frequente , è potenzialmente mortale per cui è sempre preferibile prevenirne l'insorgenza piuttosto che curare la malattia conclamata. La relazione tra patologie cardiache preesistenti, batteriemia ed insorgenza di EI è stata per la prima volta riconosciuta nel 19237. La correlazione tra la batteriemia transitoria (spesso dovuta allo Streptococcus viridans dopo estrazione dentaria) e la successiva comparsa di endocardite batterica in pazienti già affetti da malattia reumatica è stata osservata nel 19448 e costituisce il razionale per l’utilizzo di antibiotici per prevenire l’EI in pazienti che si sottopongano a cure dentarie o ad altre procedure in grado di determinare batteriemia. Mentre le precedenti linee guida (LG) focalizzavano l'attenzione sulle procedure invasive a maggior rischio di produrre batteriemia, le attuali raccomandano di sottoporre a profilassi antibiotica solo i pazienti a “maggior rischio”.
I soggetti a rischio “più elevato” di EI da sottoporre a profilassi antibiotica sono: 1) Pazienti con protesi valvolari cardiache 2) Pazienti con precedente endocardite infettiva 3) Pazienti con alcune forme di cardiopatia congenita a. cardiopatia congenita cianotica non riparata b. cardiopatia congenita riparata con materiale protesico o con device, fino a 6 mesi dopo la procedura c. cardiopatia congenita riparata ma con persistenza di difetto residuale
Questi pazienti devono ricevere una profilassi antibiotica prima di una “procedura dentaria” di qualsiasi tipo. Una buona igiene orale ed una visita dentistica periodica sono più importanti della profilassi antibiotica nel ridurre il rischio di EI. La profilassi, secondo le attuali LG, non è, invece, più raccomandata per procedure sul tratto gastrointestinale o genitourinario, per il piercing, i tatuaggi ed il parto vaginale. Per quanto riguarda il prolasso valvolare mitralico (PVM), le nuove linee guida ammettono che si tratta sicuramente della condizione più comune che, almeno in occidente, predispone all’endocardite infettiva. Tuttavia l'incidenza di questa complicanza in valore assoluto è estremamente bassa per l'intera popolazione dei soggetti con PVM e ,comunque ,non è di solito associata con outcomes gravi, come succede invece per i soggetti identificati ad alto rischio. Pertanto, per il PVM, la profilassi non è più consigliata. Lo schema antibiotico prevede l'assunzione di amoxicillina o ampicillina (2 g negli adulti, 50 mg/kg nei bambini) da 30 a 60 minuti prima della procedura. Nei soggetti allergici alla penicillina sono consigliati clindamicina (600 mg negli adulti, 20 mg/kg nei bambini)9 .
Diagnosi La diagnosi di EI certa (o definita) si pone se durante setticemia o infezione sistemica può essere dimostrato il coinvolgimento dell’endocardio, preferibilmente mediante ecocardiografia transesofagea (TEE) multiplana. Se c’è un forte sospetto clinico ma il coinvolgimento dell’endocardio non è stato dimostrato, l’endocardite deve essere classificata come “sospetta”. Se l’endocardite è solo un’alternativa nell’ambito di una diagnosi differenziale di un paziente con iperpiressia, situazione particolarmente importante qualora siano applicabili i criteri di Duke, è necessario usare il termine di EI “possibile”. Tab I
Dal momento che la presentazione clinica dei pazienti con EI è molto variabile in base all’agente patogeno riscontrato e alla presenza/assenza di patologie cardiache predisponenti e di altre patologie associate, è fondamentale per una diagnosi precoce di EI un alto indice di sospetto6.
Alto sospetto clinico di EI :
-Recente insorgenza di lesione valvolare/soffio (da rigurgito) -Evento/i embolico/i di origine sconosciuta -Sepsi di origine sconosciuta -Febbre (segno più frequente di EI) associata a: - presenza di materiale protesico all’interno delle cavità cardiache; - alto livello di predisposizione all’EI dovuto ad altre ragioni; - aritmie ventricolari o disturbi della conduzione di recente insorgenza; - prima manifestazione di insufficienza cardiaca; - emocolture positive (se gli organismi identificati sono tipici per endocardite su valvola nativa (NVE)/ endocardite su valvola protesica (PVE); - manifestazioni cutanee (Osler, Janeway) od oftalmiche (Roth); - infiltrati polmonari multifocali/a rapida evoluzione (EI del cuore destro); - ascessi periferici (renali, splenici, spinali) di origine sconosciuta; - predisposizione e recenti procedure diagnostico-terapeutiche note per causare una significativa batteriemia In conclusione, i criteri Duke introdotti nel 1994, appaiono utili a fini epidemiologici e di standardizzazione diagnostica, ma tuttavia hanno mostrato limiti sostanziali. Possono non essere sufficienti per decisioni di trattamento o per confermare od escludere la diagnosi nei casi controversi, ed il loro impiego deve essere costantemente integrato nell’ambito di un giudizio clinico generale10. Attualmente la sensibilità dei criteri Duke è stimata pari all’80%, la specificità al 94%; il valore predittivo positivo è dell’85%.
Tabella I: Criteri di Duke modificati per la diagnosi di EI10
Tre emocolture indipendenti (di cui almeno una per i microrganismi aerobi ed un’altra per gli anaerobi), ciascuna contenente 10 ml di sangue prelevati da una vena periferica con meticolosa tecnica sterile, sono quasi sempre sufficienti per identificare i microrganismi9. Le precedenti linee guida raccomandavano di effettuare il prelievo ematico in occasione del rialzo termico (al picco della febbre)9,10. Tuttavia, siccome si è visto che nell’EI, la batteriemia è quasi costante, questo ha due implicazioni: (1) non vi è ragione per ritardare il prelievo di sangue in coincidenza con i picchi di febbre, e (2) quasi tutti prelievi colturali del sangue (o la maggioranza di essi) sono positivi9.
Ecocardiografia Il ruolo dell’ecocardiografia consiste nel visualizzare le lesioni anatomiche dell’EI e valutarne le implicazioni funzionali, pertanto essa trova spazio nella diagnosi, nella stratificazione prognostica, nell’indicazione e nella conduzione della terapia medica e chirurgica. La sensibilità dell’ecocardiogramma transtoracico (TTE) su valvola nativa è di circa il 65%; con l’ecocardiogramma transesofageo (TEE) si raggiunge 85-95%. La specificità è elevata per entrambe le metodiche (90-98%). Nelle protesi valvolari il TTE ha una sensibilità ridotta al 15-35%, mentre con il TEE si raggiunge l’82-90% ed una specificità del 91-100%. Un TEE negativo implica un valore predittivo positivo tra il 91-100%11-14. In caso di sospetto clinico di EI (per esempio, in caso di febbre di origine sconosciuta), deve essere effettuato uno screening diagnostico con TTE. Se le immagini sono di buona qualità, l’esame è negativo e l’indice di sospetto clinico è basso, la presenza di endocardite è improbabile e nella diagnosi differenziale andranno prese in considerazione altre patologie. Se le immagini del TTE sono di qualità scadente la metodica di scelta è il TEE. Se il sospetto clinico è elevato (come nel caso di sepsi da stafilococco), il TEE deve essere eseguito in tutti i casi di negatività del TTE. Qualora il TEE sia negativo, ma persista un sospetto diagnostico, TTE/TEE devono essere ripetuti dopo un periodo compreso tra 7-10 giorni, per permettere che lo sviluppo delle vegetazioni le renda visibili. Un secondo esame negativo dovrebbe virtualmente escludere la diagnosi di EI, a meno che le immagini non siano di qualità scadente. Oltre nella diagnosi, le linee guida raccomandano di ripetere TTE/TEE nel “Follow-up” ( nel caso di sospetta complicanza), inoltre l’uso dell’ecocardiografia è indicato anche nella “Fase intraoperatoria” ed al “termine della terapia antibiotica” per la valutazione morfologica e funzionale delle valvole e del cuore9.
I tre reperti ecocardiografici considerati criteri maggiori per la diagnosi di EI sono i seguenti: • Vegetazione: presenza di una massa mobile, ecodensa, adesa all’endocardio valvolare o parietale, soprattutto se situata a livello dei siti preferenziali, oppure adesa a materiale protesico in assenza di altre possibili spiegazioni; • Riscontro di ascesso: spazio ecoprivo o ecodenso a seconda della composizione del materiale purulento. E’ localizzato soprattutto a livello perivalvolare, più frequentemente aortico, con possibile estensione intrasettale o intramurale e fistolizzazione. • Riscontro di deiscenza di una protesi valvolare (soprattutto se ciò avviene a distanza di tempo dall’impianto): è di norma necessario il TEE per differenziare rigurgiti intraprotesici12.
Altre alterazioni anatomiche da ricercare sono: Lacerazione o rottura di lembi o di apparati tensori valvolari Aneurisma valvolare: dilatazione sacculare, interessa soprattutto il lembo anteriore mitralico, che si espande in sistole e collassa in diastole. Pseudoaneurisma: soprattutto a livello della fibrosa intervalvolare aortica, gli ascessi possono espandersi e formare pseudoaneurismi12-14.
Trattamento Il trattamento chirurgico viene utilizzato in circa la metà dei pazienti con EI per la comparsa di gravi complicanze con insufficienza cardiaca . L’intervento chirurgico precoce in fase attiva, cioè quando il paziente è ancora sotto trattamento antibiotico, ha come indicazioni combattere i danni dell’insufficienza cardiaca progressiva ed e prevenire l'embolia sistemica. In alcuni casi, la chirurgia deve essere eseguita in “Emergenza” (entro 24 h) o in “Urgenza” (entro pochi giorni) , a prescindere dalla durata del trattamento antibiotico. In altri casi, la chirurgia può essere rinviata per consentire 1 o 2 settimane di terapia antibiotica sotto attenta osservazione clinica ed ecocardiografica prima di eseguire una procedura chirurgica di “Elezione”. Le tre principali indicazioni per la chirurgia precoce in EI sono: 1) Scompenso Cardiaco (insufficienza valvolare acuta); 2) Infezione non controllata; 3) Prevenzione degli eventi embolici Tab II. Lo “Scompenso Cardiaco” è la più frequente complicanza dell’EI e rappresenta anche la più frequente indicazione alla chirurgia. Può essere causato da insufficienza aortica o mitralica severa, fistole intracardiache, o, più raramente, da ostruzione valvolare, quando una grossa vegetazione ostruisce parzialmente l’orifizio valvolare. In caso di scompenso cardiaco l’intervento chirurgico va eseguito in urgenza oppure in emergenza (se persiste edema polmonare o shock cardiogeno, nonostante terapia medica). Le “Infezioni non controllate” sono la seconda causa più frequente di intervento chirurgico e comprendono: 1) infezione persistente (febbre persistente o emocolture positive >7-10 giorni); 2) infezione causata da miceti o da microrganismi multiresistenti; 3) infezione localmente non controllata ( ascesso, pseudoaneurisma, fistola e grossa vegetazione). Le infezioni non controllate necessitano di intervento chirurgico urgente . Gli “Eventi embolici” sono frequente complicanza mortale dell’EI, sono dovuti alla migrazione di vegetazioni cardiache. Il cervello e la milza sono i siti più frequente di embolia in caso di EI delle sezioni cardiache sinistre (aorta o mitrale), mentre l'embolia polmonare è frequente in caso di EI delle sezioni destre (tricuspide o polmonare) e su cateteri dei Pacemaker. L'ictus è una complicanza grave ed è associata con un aumento della morbilità e della mortalità. L'ecocardiografia ha un ruolo chiave nel predire gli eventi embolici. Diversi fattori sono associati con aumentato rischio di embolia, comprese le dimensioni e la mobilità delle vegetazioni, la posizione della vegetazione sulla valvola mitrale, microrganismi particolari ( stafilococchi, Streptococcus bovis, Candida ), l'embolia precedente, EI multivalvolare, e marcatori biologici. Tra questi fattori, la dimensione e la mobilità delle vegetazioni sono i più potenti fattori predittivi indipendenti di un nuovo evento embolico. Pazienti con vegetazioni di dimensioni > 10 millimetri sono a più alto rischio di embolia, e questo rischio è ancora più elevato nei pazienti con dimensioni molto grandi ( >15 millimetri) e vegetazioni mobili, soprattutto in EI stafilococciche che interessano la valvola mitrale. L’intervento chirurgico in tutte queste condizioni va sempre eseguito in urgenza9,11,12.
Situazioni specifiche Situazioni particolari di EI risultano rappresentate da: EI su Protesi valvolari (PVE), EI su Device cardiaci, EI Destre, EI in gravidanza e negli anziani. Le Endocarditi Infettive su protesi valvolari (PVE) rappresentano il 20% di tutti i casi di EI con continuo aumento dell’incidenza. La diagnosi è più difficile dell’EI su valvole native (NVE). PVE complicate, PVE stafilococciche e PVE precoci sono associate a prognosi peggiore, se non trattate chirurgicamente, e richiedono di essere gestite in modo aggressivo. I pazienti con PVE non-complicate, non stafilococciche e PVE tardive possono essere gestite in maniera più conservativa, con uno stretto follow-up. Le Endocardite Infettive su device cardiaci (CDRIE), includono quelle su elettrocateteri del Pacemaker (PMK) o dei Defibrillatori (ICD). Rappresentano una delle più difficili forme di EI da diagnosticare e devono essere sospettate in presenza di sintomi fuorvianti, in particolare nei pazienti anziani. La prognosi non è buona, soprattutto per la sua frequenza nei pazienti anziani con comorbilità associate. Nella maggior parte dei pazienti, la CDRIE deve essere trattata con terapia antibiotica prolungata e la rimozione del Device. Le Endocarditi Infettive Destre (coinvolgenti cioè la valvola tricuspide o quella polmonare) sono più frequentemente osservate nei soggetti tossicodipendenti per via endovenosa (IVDA) o affetti da cardiopatie congenite (CHD). Caratteristiche diagnostiche includono sintomi respiratori e febbre. Il TTE è di grande valore in questi pazienti. Nonostante la relativamente bassa mortalità ospedaliera, l’EI Destre hanno un alto rischio di recidiva nei tossicodipendenti ed è raccomandato in questo gruppo un approccio conservativo. Gli MSSA (ceppi di S. aureus comunemente resistenti alla penicillina ma sensibili alla meticillina) sono gli agenti eziologici coinvolti in circa il 60-70% dei casi nei tossicodipendenti9,13,14. L’Endocarditi Infettive in gravidanza è estremamente rara, e può essere una complicanza di una lesione preesistente cardiaca o la conseguenza di abuso di droghe per via endovenosa. Particolare attenzione deve essere rivolta ad una donna incinta quando presenta febbre inspiegabile ed un soffio cardiaco. La diagnosi rapida di EI ed un trattamento adeguato è importante per ridurre il rischio sia di mortalità materna che fetale9.
Tabella II Indicazioni alla Chirurgia per Endocardite Infettiva su Valvola Nativa
Bibliografia
1) Berlin JA, Abrutyn E, Strom BL et al. Incidence of infective endocarditis in the Delaware Valley, 1988-1990. Am J Cardiol, 1995; 76:933-6.
2) Hogevik H, Olaison L, Andersson R, Lindberg J, Alestig K,. Epidemiologic aspects of infective endocarditis in an urban population: a 5-year prospective study. Medicine (Baltimore), 1995; 74: 324-39.
3) Watanakunakorn C, Burkert T. Infective endocarditis at a large community teaching hospital, 1980-1990: a review of 210 episodes. Medicine (Baltimore); 1993; 72:90-102.
4) Frontera JA, Gradon JD. Right-side endocarditis in injection drug users: review of proposed mechanisms of pathogenesis. Clin Infect Dis 2000; 30: 374-9.
5) Zamorano J., Almería C., Perez Isla L et al. Beyond initial positive in-hospital outcome in patients with endocarditis. E-Journal of the ESC Council for Cardiology Practice 2010; 8 (30).
6) Horstkotte D, Follath F, Gutschik E et al. Task Force sulle Endocarditi Infettive della Società Europea di cardiologia: Linee guida sulla prevenzione, diagnosi e terapia dell'Endocardite Infettiva. Ital Heart J. Suppl 2004; 5 (7): 548-590.
7) Lewis T, Grant RT. Observations relating to subacute infective endocarditis. Heart 1923; 10: 21-99.
8) Taran LM. Rheumatic fever in its relation to dental disease. NY J Dent 1944; 14: 107-13.
9) Habib G, Hoen B, Tornos P, Thuny F, Prendergast B, Vilacosta I et al.; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). Guidelines on the prevention, diagnosis,and treatment of infective endocarditis (new version 2009): The Task Force on the Prevention, Diagnosis, and Treatment of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 2009;30:2369-413.
10) Palepu A, Cheung SS, Montessori V, et al. Factors other than the Duke criteria associated with infective endocarditis among injection drug users. Clin Invest Med 2002; 25(4): 118-25.
11) Di Salvo G, Thuny F, Rosenberg V et al. Endocarditis in the elderly: clinical, echocardiographic, and prognostic features. Eur Heart J 2003; 24:1576–1583.
12) Di Salvo G, Habib G, Pergola V et al. Echocardiography predicts embolic events in infective endocarditis. J Am Coll Cardiol 2001;37:1069–1076.
13) Horstkotte D, Follath F, Gutschik E et al. Guidelines on prevention, diagnosis and treatment of infective endocarditis executive summary; the task force on infective endocarditis of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2004;25:267–276.
14) De Tommasi S.M, Cecchi E, Conti U. et al. Endocarditi in Linee guida SIEC: 195-204. Ed. SIEC servizi Srl Milano 2009
|