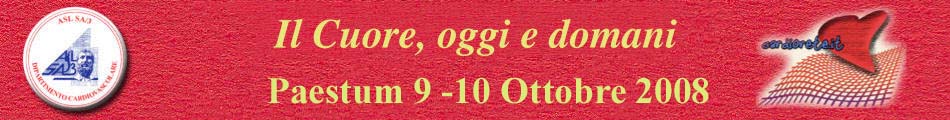
|
LA PERSONALIZZAZIONE DELLA TERAPIA DELL’IPERTENSIONE ARTERIOSA
Michele A. Tedesco, Francesco Natale Dipartimento di Cardiologia, Seconda Università di Napoli, A.O.R.N. Monaldi
L’ipertensione arteriosa rappresenta oggi la patologia con maggiore prevalenza tra le malattie croniche ed insieme agli altri fattori di rischio essa concorre a determinare il rischio cardiovascolare globale la cui corretta valutazione ha notevoli ripercussioni sulle scelte cliniche e terapeutiche. Vengono definiti ad alto rischio i pazienti con valori di pressione ≥ 180/110 mmHg, tre o più fattori di rischio, un precedente evento cardiovascolare (CV), diabete o presenza di danno d’organo (ipertrofia ventricolare sinistra, ispessimento miointimale dei vasi carotidei, danno renale lieve). Studi prospettici hanno dimostrato che, anche con valori di PA normali, i pazienti possono avere un rischio CV molto elevato in presenza di uno di questi fattori. L’esame elettrocardiografico dovrebbe essere parte della valutazione routinaria dei soggetti ipertesi per individuare la presenza di ipertrofia ventricolare sinistra, ischemia, difetti di conduzione e aritmie, pur essendo bassa la sensibilità della metodica nell’identificare la presenza di ipertrofia ventricolare sinistra (IVS). L’indice Cornell espresso come prodotto voltaggio-durata del QRS si è rivelato di grande utilità nella individuazione dei pazienti con IVS passibili di essere inclusi negli studi clinici. L’elettrocardiogramma può inoltre essere utile per identificare aspetti di sovraccarico ventricolare (strain) indicativi di un aumentato rischio cardiovascolare, ischemico e aritmico. La valutazione ecocardiografica è sicuramente più sensibile rispetto a quella elettrocardiografica nell’identificazione della presenza di IVS e nel predire il rischio cardiovascolare. La disponibilità di esami ecocardiografici è significativamente aumentata in Europa, e nei casi in cui le decisioni terapeutiche siano incerte tale esame può essere utile nel facilitare la definizione del profilo di rischio globale del soggetto e indirizzare il conseguente trattamento. La classificazione dell’ipertrofia in eccentrica e concentrica o il riscontro di rimodellamento concentrico stimato dal rapporto tra spessore della parere e raggio della cavità (valori >0,45 definiscono un profilo concentrico) si sono anch’essi rivelati predittori del rischio CV. In aggiunta, l’ecocardiografia fornisce gli strumenti per una valutazione della funzione sistolica del ventricolo sinistro tra i quali va inclusa la frazione di accorciamento centroparietale, che è stata proposta come un fattore predittivo della incidenza di eventi cardiovascolari. Inoltre, lo stesso approccio permette un esame della distensibilità diastolica del ventricolo sinistro (la cosiddetta “funzione diastolica”). Esiste un grande interesse intorno alla possibilità che aspetti ecocardiografici riconducibili alla “disfunzione diastolica” possano risultare predittivi della comparsa di dispnea e ridotta tolleranza allo sforzo in assenza di segni di disfunzione sistolica, come si osserva frequentemente nei pazienti ipertesi anziani (il cosiddetto “scompenso cardiaco diastolico”). In aggiunta, l’ecocardiografia può fornire evidenze di difetti di contrattilità della parete ventricolare conseguente alla presenza di ischemia, di un pregresso infarto del miocardio o di disfunzione sistolica. La valutazione ultrasonografica delle arterie carotidi completata dalla misurazione dello spessore del complesso intimamedia e dalla ricerca di placche ateroma siche si è rivelata in grado di predire la incidenza di ictus e infarto miocardio. Una recente revisione dei dati suggerisce che tale esame può rappresentare un utile completamento della valutazione ecocardiografica rendendo più precisa la stratificazione del rischio nella popolazione ipertesa. L’interesse crescente per la pressione sistolica e la pressione differenziale come fattori predittivi di eventi cardiovascolari, stimolato dai risultati degli studi che hanno dimostrato il beneficio della riduzione della pressione sistolica nella popolazione anziana con ipertensione sistolica isolata, ha favorito lo sviluppo di tecniche per la misurazione della compliance arteriosa delle grandi arterie. Un grande numero di evidenze fisiologiche, fisiopatologiche e terapeutiche è stato accumulato in questo ambito. L’evidenza che la pressione aortica (e conseguentemente la pressione trasmessa a livello cardiaco e cerebrale) possa essere diversa rispetto a quella misurata a livello brachiale, possa essere predittiva di eventi clinici e possa venire influenzata in maniera diversa dai vari farmaci antipertensivi. Più recentemente un grande interesse si è sviluppato per la possibilità che la disfunzione o il danno endoteliale possa rappresentare un marker precoce di danno CV. La diagnosi di danno renale indotto dall’ipertensione si basa sul riscontro di elevati livelli di creatinina sierica, di una riduzione (misurata o calcolata) della clearance della creatinina o del riscontro di una elevata escrezione urinaria di albumina al di sotto (microalbuminuria) o al di sopra (macroalbuminuria) del limite delle metodiche di laboratorio per definire la presenza di proteinuria. Un lieve incremento della creatinina sierica e della uricemia può osservarsi talvolta quando la terapia antipertensiva viene istituita o intensificata, ma ciò non deve essere considerato come un indice di deterioramento renale progressivo. La presenza di iperuricemia viene frequentemente osservata nella popolazione ipertesa non trattata e risulta correlata alla presenza di nefrosclerosi. Mentre un aumento della creatininemia indirizza verso una riduzione della filtrazione glomerulare, un incremento della escrezione urinaria di albumina o di proteine suggerisce una alterazione della barriera deputata alla filtrazione glomerulare. Nei pazienti ipertesi non diabetici la presenza di microalbuminuria, anche quando inferiore ai valori soglia di riferimento, si è dimostrata capace di predire gli eventi cardiovascolari, ed è stata recentemente descritta nella popolazione generale una relazione continua tra escrezione urinaria di albumina e la mortalità CV e non CV. Il riscontro di una alterazione della funzione renale in un paziente iperteso, espressa da uno qualsiasi dei parametri sopra ricordati, è frequente e rappresenta un elemento in grado di predire in modo accurato lo sviluppo di eventi CV futuri e il decesso del paziente stesso. In base ai risultati di diversi trials, nei pazienti ad alto rischio, la terapia antiipertensiva deve essere iniziata anche con valori inferiori a 140/90 mmHg per cercare di raggiungere valori inferiori a 130/80 mmHg. Questo obiettivo terapeutico può richiedere l’uso di più farmaci anche in terapia di combinazione sin dall’inizio per l’importanza del fattore tempo nel prevenire gli eventi CV. Il limite più importante dei trial clinici è tuttavia probabilmente rappresentato dalla sua durata temporale necessariamente ridotta nel tempo (nella maggioranza dei casi 4-5 anni), mentre le aspettative di vita, e quindi le aspettative di durata del trattamento, sono nel caso di pazienti di mezza età pari a 20-30 anni. È tuttavia possibile valutare i benefici a lungo termine della terapia e le differenze di benefici tra classi di farmaci diverse mediante l’impiego dei cosiddetti endpoint intermedi (e cioè le modificazioni del danno d’organo subclinico indotte dal trattamento). Numerose sono le evidenze che documentano che la regressione o il rallentamento della progressione del danno d’organo subclinico si associ ad una riduzione di eventi cardiovascolari, e diversi studi dimostrano che alcune delle suddette alterazioni possano avere un valore predittivo per lo sviluppo di futuri eventi fatali e non fatali. Le modificazioni indotte dalla terapia di parametri metabolici quali il colesterolo LDL o HDL, la potassiemia, la tolleranza glucidica, lo sviluppo od il peggioramento clinico dell’insulino-resistenza o del diabete, anche se raramente hanno effetti evidenziabili clinicamente nel breve corso di un trial, possono tuttavia avere importanza clinica a lungo termine nel decorso temporale della vita del paziente. Il rischio di eventi cardiovascolari, specie coronarici, è assai diverso nei due sessi. I risultati dei singoli trial clinici di intervento non consentono di chiarire se l’effetto del trattamento antipertensivo nel ridurre il rischio CV sia in qualche modo legato al sesso del paziente stesso. La metanalisi di sette studi randomizzati effettuata dal gruppo di lavoro INDANA ha consentito tuttavia di acquisire informazioni al riguardo. Il numero complessivo di pazienti valutati è stato pari a 40.777, con una percentuale di maschi del 49%. Nel sesso maschile il valore del rapporto di probabilità a favore del trattamento antipertensivo ha raggiunto significatività statistica nel caso della mortalità globale (−12%; p=0,01), cerebrovascolare (−43%; p<0,001) e coronarica (−17%; p<0,01) e per tutti gli eventi cardiovascolari fatali e non fatali (−22%, p<0,001), gli eventi ischemici cerebrovascolari (−34%, p<0,001) e coronarici (−18%, p<0,001). Nel sesso femminile, che in genere presenta un tasso di eventi inferiore rispetto al sesso maschile, il rapporto di probabilità a favore del trattamento è risultato significativo nel caso degli eventi ischemici cerebrovascolari fatali (−29%, p<0,05) e degli eventi cardiovascolari e cerebrovascolari fatali e non fatali combinati (−26%, p=0,001 e −38%, p<0,001), ma non per altri endpoint. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di risultato preso in esame, non si osservarono differenze significative tra i due sessi per quanto riguarda i rapporti di rischio tra pazienti trattati e di controllo. Inoltre, poiché non si notarono interazioni significative tra efficacia del trattamento e gentilizio è possibile concludere che la riduzione del rischio cardiovascolare indotto dal trattamento antipertensivo è simile nei due sessi. Numerosi studi hanno valutato gli effetti dei diversi farmaci antipertensivi sull’ipertrofia ventricolare sinistra associata allo stato ipertensivo, utilizzando per lo più la metodica ecocardiografica per valutare la massa ventricolare sinistra. Gli studi ELVERA , PRESERVE e FOAM hanno dimostrato una eguale efficacia degli ACE-inibitori (rispettivamente lisinopril, enalapril e fosinopril) e dei calcioantagonisti (amlodipina); lo studio CATCH ha fornito prova di efficacia simile del bloccante recettoriale dell’angiotensina candesartan nei confronti dell’ACE-inibitore enalapril. Un certo numero di studi di paragone tra bloccanti recettoriali dell’angiotensina II e l’atenololo ha dimostrato la superiorità dei sartanici rispetto ai β-bloccanti nell’indurre una regressione dell’ipertrofia cardiaca. Gli effetti favorevoli della regressione dell’ipertrofia ventricolare sinistra sono dimostrati dall’evidenza che il processo si associa ad un miglioramento della funzione sistolica. Tale beneficio è confermato dai risultati dello studio più ampio e con il più protratto periodo di osservazione mai effettuato, lo studio LIFE, che ha evidenziato che la maggiore regressione del grado di IVS, si associa ad una riduzione dell’incidenza di eventi cerebro-cardiovascolari. Numerosi studi clinici randomizzati hanno valutato in termini comparativi gli effetti a lungo termine (2-4 anni) di diverse classi di farmaci antipertensivi sullo spessore della tonaca medio-intimale dell’arteria carotide. I risultati di tali studi dimostrano in maniera uniforme che i calcioantagonisti svolgono effetti favorevoli. Uno studio controllato non ha evidenziato effetti significativi del ramipril sullo spessore della tonaca medio-intimale dell’arteria carotide, mentre in un altro studio si è osservata un significativo rallentamento della progressione dello spessore mediointimale a livello della biforcazione carotidea, della carotide interna e comune. L’analisi dei trial finalizzati a valutare gli effetti di una più o meno intensa riduzione pressoria, o della terapia attiva nei confronti del placebo, ha evidenziato che in pazienti diabetici con insufficienza renale avanzata la progressione della disfunzione renale può essere rallentata dall’aggiunta, allo schema terapeutico già impostato, di un bloccante recettoriale dell’angiotensina II (losartan o irbesartan) ma non di placebo. Effetti consistenti legati ad una maggiore riduzione dei valori pressori sono stati osservati nel caso della proteinuria e della microalbuminuria. Una recente metanalisi condotta in pazienti nefropatici non diabetici, finalizzati a paragonare tra loro trattamenti antipertensivi che prevedevano o non prevedevano l’impiego di ACE-inibitori, ha dimostrato un rallentamento della progressione della disfunzione renale significativamente maggiore nei pazienti che raggiungevano in terapia valori pressori pari a 139/85 mmHg rispetto a quanto osservato nei pazienti i cui valori pressori erano pari a 144/87 mmHg. Non è tuttavia chiaro se il maggior beneficio dipenda dall’impiego degli ACE-inibitori, come suggerito dagli Autori, o piuttosto dal raggiungimento di valori pressori più bassi. Lo studio AASK, di recente pubblicazione, non ha consentito di evidenziare in pazienti ipertesi afroamericani con nefrosclerosi un maggiore grado di rallentamento della disfunzione renale quando venivano ottenuti valori pressori di 128/78 mmHg rispetto a 141/85 mmHg. Al contrario nello stesso studio gli ACE-inibitori si sono dimostrati più efficaci dei β-bloccanti o dei calcioantagonisti nel rallentare il declino della filtrazione glomerulare. Sembra quindi che mentre nei pazienti nefropatici non diabetici l’impiego di un ACE-inibitore possa risultare più importante rispetto alla drastica riduzione pressoria, nei pazienti diabetici l’importanza dei due tipi di intervento terapeutico si equivalga. Anche in pazienti nefropatici non diabetici è comunque prudente ridurre in maniera aggressiva i valori pressori. I trial clinici che hanno valutato la comparsa di nuovi casi di diabete nel corso del follow- up dello studio hanno dimostrato una minor incidenza di diabete nel caso della terapia con ACE-inibitori e bloccanti recettoriali dell’angiotensina II. Lo studio ALLHAT ha anche evidenziato una minore incidenza di diabete nei pazienti randomizzati al trattamento con amlodipina o lisinopril rispetto a quanto osservato nei pazienti randomizzati a clortalidone. In conclusione, è importante sottolineare nella scelta dei farmaci per abbassare i valori di pressione arteriosa è opportuno preferire quelli che agendo anche sui fattori non pressione dipendenti riducono maggiormente il rischio CV globale.
Bibliografia
|