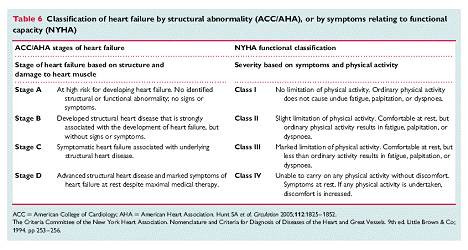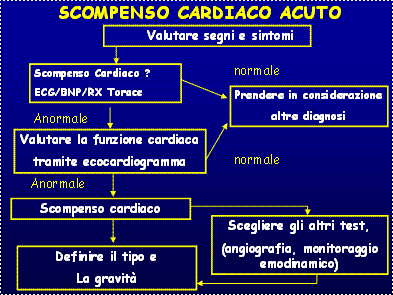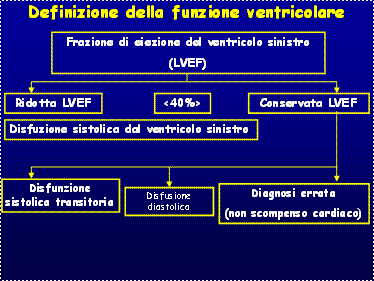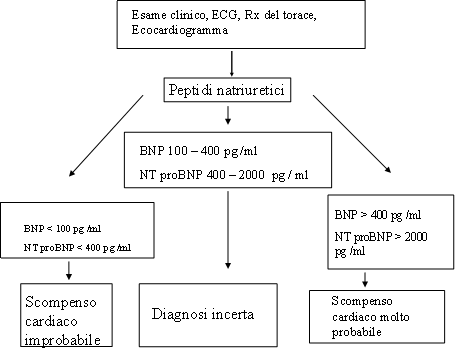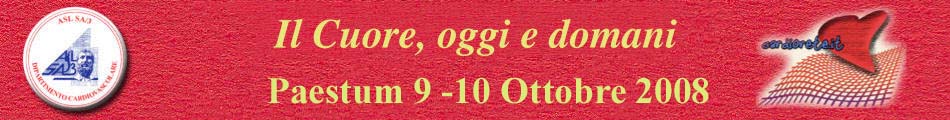
|
LO SCOMPENSO CARDIACO : DALLA DIAGNOSI ALLA STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA.
AB Scardovi UOC Cardiologia- Ospedale S. Spirito- Roma
Introduzione Lo scompenso cardiaco è una patologia ad elevata prevalenza, che colpisce l’ 1,5-2% della popolazione nel mondo occidentale e che aumenta in relazione all’eta’. Rappresenta la piu’ frequente causa di ricovero nei soggetti con eta’ maggiore di 65 anni e i costi dell’assistenza ospedaliera per la sua gestione assorbono notevoli risorse . Il progressivo invecchiamento della popolazione , la riduzione del tasso di mortalita’ per infarto acuto del miocardio e la migliore sopravvivenza dei pazienti affetti da ipertensione arteriosa , hanno provocato un progressivo incremento del numero di soggetti affetti da insufficienza cardiaca cronica. Specifiche strategie terapeutiche sono in grado di migliorare la prognosi ma la scarsa aderenza alle linee guida e le difficolta’ che spesso s’incontrano ad applicarle nei pazienti del mondo reale, ben diversi per profilo clinico a quelli disegnati nei gradi trial, ha portato a un costante aumento del numero di ospedalizzazioni per scompenso acuto. La gestione dello scompenso cardiaco assorbe 1-2% della spesa sanitaria del Paesi europei, di cui il 75% e’ per la cura del paziente ospedalizzato. Lo scompenso avanzato e lo scompenso acuto sono infatti la prima voce di costo in ambito cardiologico. Per scompenso acuto s’intende l’ improvvisa comparsa di sintomi e segni di scompenso secondari ad anomalie della funzione cardiaca sia in pazienti con disfunzione ventricolare gia’ nota ( instabilizzazione delle condizioni di compenso ) che in soggetti senza precedente storia di cardiopatia ( scompenso acuto “ de novo “ ). La disfunzione cardiaca puo’ essere dovuta a disfunzione sistolica o diastolica del ventricolo sinistro ,a scompenso del ventricolo destro , ad aritmie o a discrepanza tra pre o post- carico. Lo scompenso acuto richiede ricovero e trattamento urgente in quanto e’ una patologia grave che puo’ essere letale. La mortalita’ per quanto riguarda l’infarto acuto del miocardio complicato da scompenso raggiunge il 30% a 12 mesi. Nell’edema polmonare acuto la mortalita’ intraospedaliera e’ del 12% e del 40% ad un anno. Nella survey italiana sullo scompenso cardiaco acuto la mortalita’ totale intraospedaliera e quella a sei mesi sono state rispettivamente del 7.3% e del 12.8% mentre il tasso di riospedalizzazione nei sei mesi dopo la dimissione era del 38,1%.. La definizione di scompenso cardiaco acuto include quadri fisiopatologici molto diversi tra loro che possono comportare strategie terapeutiche differenti. Si possono distinguere vari tipi di scompenso acuto che differiscono per eziologia e/o causa scatenante :
(1) Instabilizzazione in scompenso cardiaco cronico (2) Scompenso che complica una sindrome coronarica acuta (a) Scompenso in paziente con disfunzione post - ischemica del ventricolo sinistro (b) Scompenso da complicanze meccaniche relative ad IMA (c) Scompenso da infarto del ventricolo destro (3) Scompenso in corso di crisi ipertensiva (4) Scompenso in corso di aritmia acuta (TV, FV, FA, TPSV) (5) Scompenso in paziente con cardiomiopatia ad eziologia non ischemica (6) Rigurgiti valvolari (7) Stenosi aortica (8) Miocardite acuta (9) Tamponamento cardiaco (10) Dissecazione aortica (11) Cardiomiopatia post – parto
L’instabilizzazione delle condizioni di compenso puo’ essere causata da una serie di fattori non cardiovascolari che comprendono la scarsa aderenza alla terapia medica,il sovraccarico di volume , le infezioni ( in genere polmonari ), l’ictus con grave danno cerebrale, gli interventi di chirurgia maggiore, l’insufficienza renale,l’anemia, la tireotossicosi, le crisi d’asma ed infine l’ abuso di stupefacenti e/o di bevande alcoliche. Per scompenso cardiaco cronico s’intende una sindrome complessa caratterizzata da uno stato fisiopatologico nel quale le anomalie della funzione cardiaca hanno danneggiato la funzione di pompa del cuore che non e’ piu’ in grado di fornire un apporto adeguato di sangue per soddisfare le necessita’ metaboliche dei vari organi e apparati . Esistono varie classificazioni dello scompenso cardiaco cronico. Le piu’ utilizzate sono quella NYHA, che definisce l’entita’ della compromissione funzionale provocata dallo scompenso suddividendola in 4 classi di crescente gravita’ ( dalla I alla IV ), e la piu’ recente, in 4 stadi da A a D, che si basa essenzialmente sulla struttura e sull’entita’ del danno del muscolo cardiaco associata alla presenza o meno di sintomi. Diagnosi
La diagnosi di scompenso cardiaco viene formulata attraverso una attenta valutazione clinico – anamnestica e strumentale. La valutazione clinica si avvale di una serie di segni e sintomi che comprendono la presenza di dispnea,di angor, il rilievo di rantoli polmonari, edemi declivi, congestione epatica , turgore giugulare, soffi cardiaci, ritmo di galoppo all’ascoltazione cardiaca .L’ anamnesi personale e familiare del paziente sono di fondamentale importanza . Tramite la classificazione NYHA e’ infatti possibile delineare l’entita’ della compromissione funzionale del paziente . Tra gli esami strumentali ricoprono un ruolo di primo piano l’ elettrocardiogramma, la radiografia del torace ( ingrandimento dell’ombra cardiaca, segni di congestione polmonare ), la valutazione della saturazione di O2 .
TAB 1- Classificazione dello scompenso ( dalle linee Guida Europee 2008 )
L’ ecocardiogramma doppler con la misurazione degli spessori , dei diametri e dei volumi delle cavita’ cardiache, il calcolo della frazione di eiezione, la valutazione della funzione e della struttura delle valvole cardiache e, di fondamentale importanza, lo studio del riempimento diastolico , deve essere effettuato in tutti i pazienti che presentano segni e sintomi fortemente sospetti per scompenso cardiaco . Per quanto riguarda gli esami di laboratorio sono particolarmente utili oltre agli esami di routine ( creatininemia, azotemia, elettrolitemia, emocromo, transaminasi, PCR, INR ed emogasanalisi ) il dosaggio dei peptici natriuretici e della troponina. Il dosaggio dei peptici natriuretici BNP e NT-proBNP ( anche con metodica rapida “ point – of – care “ ) negli ultimi anni ha assunto un ruolo di primo piano nell’escludere o confermare la presenza di scompenso cardiaco ove gia’ esista il sospetto clinico della malattia. Bisogna comunque tener conto che altri fattori, oltre allo scompenso, possono influenzare la concentrazione plasmatica di BNP/NT-proBNP, in particolare l’obesità, fattori genetici e anche la presenza di disfunzione renale, epatica o polmonare e il trattamento farmacologico. Per questo motivo esistono differenze nella definizione delle “soglie” di discriminazione fra “patologico” e “normale”, legate sia alla natura del peptide misurato (BNP, NT-proBNP) che al metodo analitico scelto. Inoltre la concentrazione plasmatica dei peptici natriuretici tende ad aumentare con l’età e ad essere più elevata nelle donne rispetto agli uomini. Non ostante questi motivi di cautela il dosaggio di BNP/NT-proBNP e’ un ausilio valido alla diagnosi di scompenso cardiaco. La sua utilita’ in questo campo di applicazione risiede soprattutto nell’alto valore predittivo negativo di concentrazioni ematiche ridotte di questi peptidi. La metodica standard per diagnosticare la disfunzione ventricolare sinistra resta comunque l’ecocardiografia per la quale una frazione di eiezione inferiore al 45% definisce la disfunzione sistolica . La diagnosi di disfunzione diastolica è meno standardizzata e più controversa e si basa essenzialmente sui dati derivabili tramite l’ ecocardiogramma doppler con lo studio del velocitogramma mitralico ed in particolare sulla misurazione del tempo di decelerazione dell’onda E e sull’analisi del rapporto tra onda A e onda E .I peptidi natriuretici aumentano sia in caso di disfunzione sistolica che diastolica, sebbene il grado di correlazione con i parametri ecocardiografici sia variabile nei vari studi pubblicati. Poiché nella pratica vi è un’alta frequenza di diagnosi cliniche falsamente positive, specialmente nelle donne, l’utilizzo del dosaggio dei livelli ematici dei peptidi natriuretici è consigliato nelle linee guida della Società Europea di Cardiologia anche per aumentare la percentuale di diagnosi appropriate o per escludere la presenza di scompenso cardiaco specialmente in PS : un aumento della concentrazione ematica dei peptidi natriuretici fa porre indicazione ad un approfondimento mediante ulteriori indagini strumentali. I valori soglia da utilizzare sono 100 pg /ml per il BNP e 400 pg /ml per quanto riguarda il dosaggio di NT- pro – BNP ,che e’ il precursore inattivo del BNP ed ha una concentrazione ematica piu’ alta e quindi una scala di valori di riferimento diversa. Il test ergometrico, o meglio quello cardiopolmonare con la misurazione dei gas espirati durante esercizio, e’ un metodo utile per definire l’entita’ della compromissione funzionale e per individuare la presenza o meno d’ischemia da sforzo. Il rilievo di un consumo di ossigeno normale al picco dell’esercizio ( PVO2 ) , in un paziente non trattato per insufficienza cardiaca, porta ad escludere la diagnosi di scompenso cardiaco sintomatico. Un’utile alternativa e’ rappresentata dal test del cammino dei 6 minuti che e’ uno strumento semplice e universalmente disponibile per la valutazione della capacita’ funzionale. Nei pazienti con sospetto scompenso cardiaco nei quali l’ecocardiografia basale non fornisce informazioni esaurienti , possono essere effettuate ulteriori indagini strumentali quali la risonanza magnetica nucleare ( RM ), la TAC coronarica o la scintigrafia miocardia. La RM e’ una metodica riproducibile, non invasiva utile per definire la struttura e la funzione delle cavita’ cardiache e del pericardio. La RM con mezzo di contrasto ( gadolinio ) e’ utile per definire stati infiammatori, infiltrativi e l’entita’ di una cicatrice infartuale. I suoi limiti sono i costi, la disponibilita’ dell’apparecchiatura e dell’operatore esperto e la non applicabilita’ nel paziente aritmico o portatore di pace – maker . La TAC coronarica serve a definire l’anatomia coronarica e puo’ essere presa in considerazione nel paziente con bassa probabilita’ pre – test di coronaropatia, per escluderne la presenza, o in caso di test provocativo d’ischemia dubbio per decidere se procedere o meno ad effettuare la coronarografia. Bisogna comunque tenere conto che la dimostrazione anatomica di aterosclerosi coronarica non implica di per se’ la presenza d’ischemia. La ventricolografia con radionuclidi e’ una metodica piuttosto accurata , ma con dei limiti nella misurazione dei volumi, per definire la frazione di eiezione del ventricolo sinistro ed e’ in genere effettuata nel corso di una valutazione della perfusione miocardica per la ricerca d’ischemia e di vitalita’. I test di funzionalita’ respiratoria hanno un ” ruolo di nicchia “ nell’iter diagnostico dello scompenso cardiaco ma possono essere utili per escludere l’origine respiratoria della dispnea . La registrazione continua dell’elettrocardiogramma per 24 ore secondo Holter puo’ essere utile nei pazienti con sintomi attribuibili ad aritmia ( palpitazioni, sincope ), per rivelare la presenza di aritmie maggiori ventricolari ( tachicardia ventricolare ) e sopraventricolari e per individuare episodi d’ischemia silente. La coronaroventricolografia non ha un ruolo nel work up diagnostico dello scompenso cardiaco ma e’ indicata per precisare l’eziologia dello scompenso , in vista di eventuale rivascolarizzazione coronarica, prima di un intervento di sostituzione valvolare . Per quanto riguarda il cateterismo del cuore destro fornisce importanti informazioni sulle pressioni di riempimento . sulle resistenze vascolari e sulla gittata cardiaca sia basali che durante stimolo farmacologico. Non e’ indicato per la diagnosi di scompenso cardiaco ma puo’ esserlo in caso di scompenso refrattario e di valutazione per inserimento in lista d’attesa per trapianto cardiaco. Non ostante il suo utilizzo non si sia dimostrato efficace per migliorare la prognosi , puo’ essere utile in caso di shock cardiogeno per monitorare la risposta al trattamento. La biopsia endomiocardica deve essere presa in considerazione nei casi di scompenso acuto , fulminante di eziologia incerta refrattario alla terapia , nelle forme infiltrative ( amiloidosi, sarcoidosi, emocromatosi ), nel sospetto di miocardite eosinofila e nelle forme restrittive ad eziologia incerta.
. Fig 1 Algoritmo per la diagnosi di scompenso cardiaco
Fig 2 Definizione della funzione ventricolare
Tab 2
Tabella 2 RUOLO DEL DOSAGGIO DEL BNP / NT-proBNP NELLA DIAGNOSI , NELLA GESTIONE CLINICA E NELLA STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA DEL PAZIENTE CON SCOMPENSO ACUTO
Fig 3. Flow – chart per la diagnosi di scompenso cardiaco tramite l’utilizzo dei peptici natriuretici in pazienti non trattati con sintomi sospetti per scompenso. ( dalle lineee Guida Europee 2008 ).
STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA La stratificazione del rischio del paziente affetto da scompenso cardiaco e’ complessa in quanto la prognosi dipende da molteplici fattori quali l’ eta’, l’eziologia , le co- morbilita’. L’andamento della malattia puo’ variare dalla forma che porta a morte per scompenso progressivo e refrattario a quella caratterizzata dalla morte improvvisa. E’ difficile inoltre prevedere la risposta alla terapia nel singolo paziente.Le variabili che sembrano avere una predittivita’ maggiore sono: l’eta’, l’eziologia ischemica, l’essere stati rianimati dopo un arresto cardiaco, la scarsa compliance alla terapia, l’anemia, l’insufficienza renale ( anche lieve ), il diabete, la brocopneumopatia cronica ostruttiva, la depressione. Dal punto di vista clinico i parametri piu’ importanti da considerare sono: l’ipotensione, la classe funzionale NYHA avanzata ( III- IV ),l’ aver subito precedenti ospedalizzazioni specialmente se multiple, la tachicardia, la presenza di rantoli polmonari, un ridotto indice di massa corporea, la concomitanza di stenosi aortica e le anomalie della respirazione durante il sonno. I criteri elettrocardiografici di cui tener conto sono : la tachicardia, la presenza di onde Q, lo slargamento del QRS, l’ipertrofia ventricolare sinistra, le aritmie ventricolari complesse, una ridotta variabilita’ dell’intervallo R- R, la fibrillazione atriale e la presenza di alternanza dell’onda T. Tra i parametri rilevabili durante esercizio fisico spiccano la ridotta capacita’ lavorativa, un basso VO2 di picco al test cardiopolmonare, una scarsa capacita’ di cammino al 6- minute walking test, la presenza di risposta iperventilatoria all’esercizio identificata da un VE / VCO2 slope elevato al test cardioplomonare, la presenza di respiro periodico. Nell’ambito dei dati di laboratorio la predittivita’ piu’ alta e’ quella legata ad elevati valori di BNP / NT pro BNP, seguono l’iponatremia, l’elevazione della troponina, l’aumento dell’azotemia, dell’uricemia e della bilirubinemia. All’interno delle metodiche strumentali il potere prognostico maggiore e’ appannaggio di parametri derivabili dall’ecocardiogramma doppler quali la frazione di eiezione, l’aumento dei volumi cardiaci, un basso indice cardiaco ed elevate pressioni di riempimento identificate da un profilo di tipo restrittivo al doppler transmitralico, l’ipertensione polmonare e la disfunzione del ventricolo destro. Il valore prognostico del BNP e del NT- proBNP e’ stato dimostrato da numerosissimi studi condotti sia in pazienti con scompenso cardiaco conclamato che con semplice disfunzione ventricolare sinistra in fase pre - clinica. Il tasso plasmatico di BNP e’infatti in grado di riflettere in modo affidabile le pressioni di riempimento del ventricolo sinistro e puo’ quindi essere un utile surrogato del monitoraggio emodinamico invasivo in terapia intensiva. Il dosaggio del BNP fornisce pertanto un parametro aggiuntivo per la stratificazione del rischio in pazienti con scompenso cardiaco acuto e cronico . Gli effetti della terapia sul tasso ematico di BNP sono stati ampiamente dimostrati in letteratura : nei pazienti con scompenso cardiaco adeguatamente trattati con diuretici e vasodilatatori i livelli plasmatici di BNP si riducono parallelamente alla riduzione delle pressioni di riempimento del ventricolo sinistro . Anche gli ace- inibitori , gli inibitori dei recettori dell’angiotensina II, e lo spironolattone, un antagonista dell’aldosterone , hanno dimostrato di essere in grado di ridurre la concentrazione ematica di BNP. Per quanto riguarda l’effetto dei farmaci beta-bloccanti sull’andamento del BNP la questione è più complessa. Da una parte, poiché la stimolazione adrenergica inibisce il rilascio di peptidi natriuretici, la somministrazione della terapia beta-bloccante nelle prime fasi può provocare modesti rialzi delle concentrazioni di BNP anche per un possibile effetto di “ down” regulation sui recettori di “clearance” ed uno di “ up regulation” sui recettori di attività . D’altra parte, poiché il trattamento con beta-bloccanti alle lunghe distanze é in grado di migliorare i parametri emodinamici e la funzione ventricolare sinistra, l’effetto finale sul BNP é quello di ridurne la concentrazione . Il dosaggio del BNP puo’ inoltre essere particolarmente utile nella scelta del momento migliore in cui programmare la dimissione . In questo ambito d’incertezza , dove anche gli esami strumentali come l’ecocardiogramma doppler falliscono nel suddividere in modo efficace la popolazione dei pazienti nelle varie fasce di rischio, il dosaggio plasmatico del BNP rappresenta un parametro biologico semplice che si e’ dimostrato molto valido nel confermare o meno il giudizio clinico di stabilita’ al momento della dimissione ,dopo un episodio di scompenso acuto. Esistono infatti varie testimonianze in letteratura che dimostrano come il tasso di BNP al momento della dimissione sia fortemente correlato con la prognosi a breve termine. Il suo dosaggio quindi rappresenta uno strumento valido per decidere il momento migliore per dimettere il paziente e per pianificare il modo adeguato il follow up e le scelte terapeutiche successive. Nella scelta tra dosaggio di BNP e di NT – pro BNP bisogna tener conto che , nonostante le differenze tra i due test ematici siano notevoli , per ambedue i dosaggi vi sono dimostrazioni scientifiche a sostegno della loro validita’ sia nella diagnosi che nella stratificazione prognostica dello scompenso cardiaco acuto quindi la scelta deve avvenire in base al tipo di test disponibile. E’ comunque fondamentale confrontare i dati relativi ad uno stesso tipo di test in quanto, come gia’ detto in precedenza, non condividono la stessa scala di riferimento. Per quanto riguarda l’utilizzo del BNP nella gestione intraospedaliera del paziente con scompenso cardiaco acuto non vi sono ancora indicazioni nelle linee guida ma dimostrazioni sempre piu’ convincenti riguardo all’importanza del suo ruolo nei lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali . Negli ultimi anni sono stati fatti molti tentativi di combinare i vari test e parametri disponibili per ottenere una piu’ fine stratificazione prognostica del paziente con scompenso cardiaco. Uno degli esempi piu’ significativi e’ lo score di Seatlle che, per mezzo della combinazione di semplici variabili cliniche , dati di laboratorio e informazioni sulla terapia in corso, e’ in grado di delineare affidabilmente la prognosi a 1, 2 e 3 anni di pazienti con scompenso cardiaco cronico da disfunzione sistolica del ventricolo sinistro. Dall’analisi della nostra casistica personale, composta da pazienti con scompenso cardiaco cronico da disfunzione sistolica, diastolica e sisto – diastolica del ventricolo sinistro,valutati presso l’ambulatorio scompenso in fase di stabilita’ clinica e con terapia ottimizzata , sono emerse varie informazioni interessanti : la frazione di eiezione del ventricolo sinistro non sembra essere un parametro determinante della prognosi, il BNP ha un valore prognostico importante ma inferiore a quello del rilievo di risposta iperventilatoria all’esercizio durante test cardiopolmonare ed e’ quindi fondamentale , quando possibile, effettuare quest’ultimo in quanto e’ in grado di fornire informazioni complete ed esaurienti circa la funzionalita’ cardiaca, respiratoria e muscolare. Il test cardioplmonare e’ infatti sicuro, affidabile ed effettuabile anche nei pazienti anziani , rappresentando un ottimo e raffinato strumento per la stratificazione del rischio in tutte le categorie di pazienti con scompenso cardiaco, al di la’ dell’indicazione al trapianto cardiaco, e per questo se ne auspica una piu’ larga diffusione all’interno dei centri cardiologici che si occupano di scompenso cardiaco.
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
1. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008. The task force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC ( HFA ) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine ( ESICM ). Eur Heat J 2008, 1 – 55. 2. Bohom M , Cowie MR; Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Acute Failure of the European Society of Cardiology Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: executive summary . Eur Heart J 2005 ;26: 384 - 416. 3. LB Daniels, AS Maisel. Natriuretic Peptides. State-of-the-art paper. J Am Coll Cardiol 2007,50,25; 2357 – 68. 4. Levy WC, Mozzaffarian D, Linker DT, et al The Seattle Heart Failure Model. Prediction of survival in heart failure. Circulation 2006; 113: 1424 – 1433.
5. Latini R, Masson S, Anand I, et al. Effects of valsartan on circulating brain natriuretic peptide and norepinephrine in symptomatic chronic heart failure: the Valsartan Heart Failure Trial (Val-HeFT). Circulation 2002; 106: 2454-58
6. The RESOLVD Investigators. Effects of metoprolol CR in patients with ischemic and dilated cardiomyopathy: the randomised evaluation of strategies for left ventricular dysfunction . Pilot study. Circulation 2000; 101: 378-8 7. Kawai K, Hata K, Takaoka H, Kawai H, Yokoyama M. Plasma brain natriuretic peptide as a novel therapeutic indicator in idiopathic dilated cardiomyopathy during beta-blocker therapy: a potential of hormone-guided treatment. Am Heart J 2001; 141: 925-32 8. Doust JA, Pietrzak E, Dobson A, Glasziou P How well does B- type ntriuretic peptide predict death and cardiac events in patients with heart failure: systematic review. BMJ 2005 Mar 19; 330 ( 7492 ): 625
9. Logeart D., Saudubray C., Beyne P., et al. Comparative value of doppler echocardioraphy and B- type natriuretic peptide assay in the etiologic diagnosis of acute dyspnea. J Am Coll Cardiol 2002 ; 40 : 1794 – 800. 10. Stuthers A.D. Identification, diagnosis and treatment of heart failure : could we do better ? Cardiology 1996; 87 Suppl 1 : 29 - 32 11. Maisel A.S., McCord J., Nowak R.M., et al Bedside B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure with reduced or preserved ejection fraction. Results from the Breathing Not Properly Multinational Study. J Am Coll Cardiol 2003;41: 2010 . 12. Scardovi AB, De Maria R, Celestini A, Perna S, Coletta C, Feola M, Aspromonte N, Rosso G, Carunchio A, Ferraironi A, Pimpinella A, Ricci R. The additive prognostic value of the cardiopulmonary exercise test in elderly patients with heart failure. Clin Sci (Lond). 2008 Aug 12. 13. Scardovi AB, De Maria R, Celestini A, Coletta C, Aspromonte N, Perna S, Parolini M, Ricci R.Prognostic value of brain natriuretic peptide and enhanced ventilatory response to exercise in patients with chronic heart failure.Intern Emerg Med. 2008 Jun 17. 14. Scardovi AB, De Maria R, Coletta C, Aspromonte N, Perna S, Cacciatore G, Parolini M, Ricci R, Ceci V. Multiparametric risk stratification in patients with mild to moderate chronic heart failure.J Card Fail. 2007 Aug;13(6):445-51. 15. Scardovi AB, Coletta C, De Maria R, Perna S, Aspromonte N, Feola M, Rosso G, Greggi M, Ceci V The cardiopulmonary exercise test is safe and reliable in elderly patients with chronic heart failure. J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2007 Aug;8(8):608-12. 16. Scardovi AB, Coletta C, Aspromonte N, Perna S, Greggi M, D'Errigo P, Sestili A, Ceci V. Brain natriuretic peptide plasma level is a reliable indicator of advanced diastolic dysfunction in patients with chronic heart failure. Eur J Echocardiogr. 2007 Jan;8(1):30-6. Epub 2006 Feb 14 17. Scardovi AB. Clinical applications of brain natriuretic peptide testing. Ital Heart J Suppl. 2004 May;5(5):343-56. Review. Italian. |